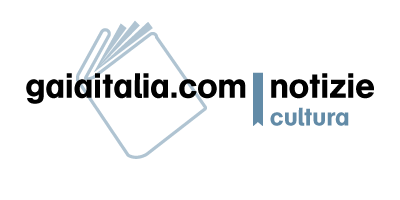di Alessandro Paesano twitter@Ale_Paesano
di Alessandro Paesano twitter@Ale_Paesano
O della nostalgia di e con Matteo Angius e Riccardo Festa presentato a Short Theatre 10 è uno spettacolo che chiama i due personaggi attori e il pubblico che vi assiste a ragionare sul significato della nostalgia.
Per farlo usa l’escamotage, un po’ pretestuoso, del programma radiofonico che dovrebbe dare forma alla messinscena (un programma radiofonico registrato dal vivo e poi mandato in onda in differita, a rimarcare lo scarto temporale tra un qui e un altrove come esempio di nostalgia), ma che viene subito abbandonato: l’allestimento non rispetta i tempi e i ritmi dei normali programmi radiofonici la registrazione audio scandendo solamente la durata dell’esecuzione (con tanto di timer) di una performance libera nella quale i due autori interpreti possono condurre la ricerca sulla nostalgia a partire dai propri ricordi, confrontandoli con un immaginario collettivo condiviso (anche con il pubblico) il cui collante è generazionale (entrambi gli interpreti sono quasi quarantenni).
Anche le didascalie che dividono lo spettacolo in tre parti e che vengono videoproiettate senza che i due performer ne facciano menzione alcuna fanno parte di un paratesto che non contempla la registrazione audio (per la quale rimane del tutto invisibile).
O della nostalgia è un lavoro discontinuo che alterna momenti più riusciti nei quali l’ironia sottile e impalpabile induce a non prendere troppo sul serio l’esposizione pubblica di un sentimento intimo e privato come quello nostalgico, il cui vissuto emotivo si banalizza sempre un poco quando viene reso pubblico, ad altri momenti in cui il narcisismo della performance (se non dei due personaggi attori) prende il sopravento e rischia di far (s)cadere il discorso in un autoreferenzialismo fine a sé stesso.
Adolescenziale è il modo in cui i due personaggi irridono (in realtà quasi vantandosi) delle proprie idiosincrasie la più emblematica delle quali è un desiderio di paternità nominale che si espleta solamente nel concepimento e non nella crescita della prole, senza che se ne traggano le debite conseguenze da un punto di vista generazionale, sociale, antropologico e politico (nel senso di vita nella città, cioè collettivo).
Il vanto si attesta ad un’autoindulgenza senza scalfire davvero il guscio di un ego maschile contemporaneo votato al disimpegno, come i due performer individuano facendone però mero esercizio di ostensione e non di critica.
Un disimpegno nemmeno davvero intimo e personale troppo mediato dall’immaginario collettivo per manifestarsi davvero e diventare oggetto di analisi e critica.
La verve performativa dei due interpreti – che dialogano e giocano col pubblico, declamano poesie improvvisate, offrono alla platea diverse versioni moderne della madeleine proustiana (dalle galatine alle rossana alla colla coccoina per fare solo qualche esempio) – è brillante, ma indugia in certe imperdonabili (oltre che scontate) scivolate maschiliste come l’accenno alla pornografia quale correlativo oggettivo dell’autoerotismo maschile (necessariamente ed esclusivamente etero) che serve solo a confermare lo stereotipo di una donna sottomessa (mostrata in alcune pose pornografiche videoproiettate) a uso e consumo dei maschi etero senza irriderne o metterne in discussione il portato sessista (e nemmeno il primato eterosessista) che non viene nemmeno preso in considerazione.
Lo spettacolo sa anche raggiungere momenti di alta emotività. Angius, colto a messaggiare col cellulare in scena, costretto a condividere il contenuto del testo che sta digitando, legge il messaggio quotidiano che manda a un amico, morto ormai da oltre trecento giorni… Il silenzio assoluto in sala, dopo, è il momento più alto dell’intero spettacolo e la dimostrazione di quando il lavoro sappia coinvolgere il pubblico.
Manca alla messinscena una vera sfrontatezza, che faccia correre qualche rischio vero sia al pubblico che ai due performer. Invece, nonostante le apparenze, la quarta parete del teatro borghese è salda e integra più che mai.
Alla fine, la nostalgia, evocata e interrogata nella sua esistenza dal testo, compare nello spettacolo sotto forma di assenza, negli interstizi dell’immaginario collettivo di una generazione che sembra essere rimasta adolescente, non interessata a entrare nelle cose rimanendo alla superficie di un privato che non riesce mai a diventare politico senza che questa empasse venga effettivamente colta nella sua estrema attualità culturale.
Un limite che non è certo imputabile esclusivamente ai due autori ma che inchioda tutti e tutte pubblico e performer, alle proprie responsabilità.
Angius e Festa portano in scena la questione senza accorgersi che si tratta di un problema.
Ed ecco che la nostalgia acquista subito un altro sapore, un altra prospettiva, un significato altro probabilmente anche al di là di quanto non vogliano i due autori interpreti.
(8 settembre 2015)
©gaiaitalia.com 2015 – diritti riservati, riproduzione vietata