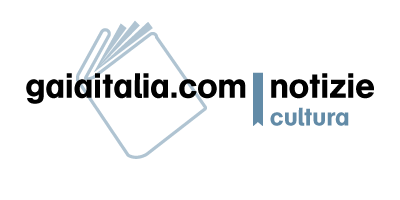di Fabio Galli
In “L’arte sopravvivrà alle sue rovine”, Anselm Kiefer si confronta con uno dei temi più profondi e universali della storia dell’arte e della cultura: la resistenza della creazione umana nel tempo, anche di fronte alla distruzione, al decadimento e all’oblio. Pubblicato nel 2022, il libro rappresenta una summa del pensiero dell’artista tedesco, la cui opera è stata sempre attraversata da una riflessione costante sulla memoria, sulle macerie della storia e sulla capacità dell’arte di trasformare la distruzione in nuova vita.
Kiefer, noto per le sue monumentali installazioni e per il suo utilizzo di materiali destinati al degrado – piombo, cenere, legno carbonizzato, paglia –, sviluppa in queste pagine una poetica della rovina che non è mai pura nostalgia o melanconia, ma piuttosto un invito a guardare la distruzione come parte integrante del processo creativo. Non è un caso che le sue opere sembrino spesso archeologie del presente, testimonianze di una civiltà in bilico tra la volontà di ricordare e la tendenza all’oblio. In L’arte sopravvivrà alle sue rovine, questa visione si fa ancora più esplicita: l’arte, anche quando sembra scomparire, non è mai del tutto perduta.
Il libro è costruito come una stratificazione di testi e immagini che dialogano tra loro, senza una divisione netta tra teoria e pratica. È un’opera che riflette il linguaggio stesso di Kiefer, il cui lavoro si basa su un accumulo di segni, materiali e riferimenti culturali che si sovrappongono e si contaminano. La memoria, in questo contesto, non è mai fissa o definitiva, ma sempre in movimento: un palinsesto che può essere letto in modi diversi a seconda del tempo e dello sguardo di chi lo osserva.
LE ROVINE COME LINGUAGGIO DEL TEMPO
Sin dall’antichità, le rovine hanno avuto un fascino ambivalente: da un lato, sono simboli della caducità di tutte le cose umane; dall’altro, rappresentano ciò che sopravvive al tempo, le tracce di un passato che si rifiuta di svanire completamente. Per Kiefer, il concetto di rovina non è solo un tema iconografico, ma una vera e propria metodologia artistica. Le sue opere non cercano la perfezione formale, ma anzi abbracciano l’idea di incompiutezza e di deterioramento, come se fossero esse stesse destinate a diventare rovine.
Nel libro, questa idea viene esplorata attraverso riferimenti a filosofi, poeti e pensatori che hanno riflettuto sul tema della distruzione e della memoria. Da Walter Benjamin ad Aby Warburg, da Paul Celan a Hölderlin, Kiefer attinge a una tradizione intellettuale che vede nella rovina non solo la fine, ma anche un nuovo inizio. Benjamin, ad esempio, sosteneva che il passato può essere compreso solo attraverso i suoi frammenti, attraverso ciò che resta dopo il crollo di una civiltà. Kiefer sembra condividere questa visione, costruendo un’estetica della frammentazione in cui ogni opera è un dialogo tra ciò che è stato e ciò che potrebbe ancora essere.
Un esempio emblematico di questa poetica è il modo in cui Kiefer utilizza i libri bruciati nelle sue opere. La cenere e le pagine annerite non rappresentano solo la distruzione del sapere, ma anche la sua persistenza: ciò che è stato scritto non può essere cancellato del tutto, perché continua a esistere nella memoria e nella coscienza collettiva. In L’arte sopravvivrà alle sue rovine, questo concetto viene ampliato fino a diventare un principio generale: ogni atto di distruzione porta con sé i semi di una nuova creazione.
L’ARTE COME TESTIMONE DELLA STORIA
Uno degli aspetti più affascinanti del libro è la sua riflessione sul ruolo dell’arte nella conservazione della memoria storica. Kiefer ha sempre avuto un rapporto complesso con la storia, in particolare con quella della Germania del XX secolo. Nato nel 1945, subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, ha vissuto l’infanzia in un paese segnato dalla colpa e dalla necessità di fare i conti con il proprio passato. Questo contesto ha influenzato profondamente il suo lavoro, spingendolo a interrogarsi su come l’arte possa confrontarsi con le ferite della storia senza cadere nella retorica o nella glorificazione.
In “L’arte sopravvivrà alle sue rovine”, Kiefer affronta questo tema con lucidità, mostrando come l’arte non possa mai essere neutrale rispetto alla storia. Le sue opere sono spesso ispirate a eventi storici precisi, ma invece di rappresentarli in modo didascalico, li trasformano in simboli universali della fragilità umana. Le rovine che dipinge o costruisce non sono solo quelle della Germania postbellica, ma quelle di ogni civiltà che ha conosciuto la guerra e la distruzione.
Questa visione si ricollega a una lunga tradizione artistica che ha visto nella rovina un simbolo della condizione umana. Già nel Rinascimento, artisti come Piranesi e Claude Lorrain avevano raffigurato paesaggi in cui i resti dell’antichità si mescolavano alla natura, suggerendo un senso di malinconia per ciò che è perduto. Kiefer riprende questa tradizione, ma la porta in una direzione più radicale: nelle sue opere, la rovina non è solo un elemento estetico, ma una realtà materiale, costruita con materiali che si deteriorano nel tempo.
Nel libro, questa idea viene sviluppata attraverso una serie di riflessioni sulla relazione tra arte e distruzione. Kiefer mostra come ogni epoca abbia tentato di cancellare ciò che l’ha preceduta, ma allo stesso tempo abbia sempre lasciato delle tracce che non possono essere eliminate del tutto. L’arte, in questo senso, è una forma di resistenza: un modo per mantenere viva la memoria anche quando tutto sembra destinato a scomparire.
UN LIBRO CHE È ESSO STESSO UNA ROVINA
Alla fine della lettura di “L’arte sopravvivrà alle sue rovine”, si ha la sensazione che il libro stesso sia costruito come un’opera di Kiefer: un insieme di frammenti che si accumulano, si sovrappongono e si trasformano nel tempo. Non è un semplice saggio, né un catalogo di opere, ma qualcosa di più simile a un diario di pensieri, a una riflessione in continua evoluzione.
Ciò che emerge con forza è l’idea che l’arte non sia qualcosa di statico, ma un processo in perenne movimento. Anche quando un’opera viene distrutta, il suo significato può sopravvivere in altre forme: nelle memorie di chi l’ha vista, nelle influenze che lascia su altri artisti, nelle reinterpretazioni future. Questa è la vera lezione di Kiefer: l’arte non può essere cancellata, perché la sua essenza è proprio quella di trasformarsi e adattarsi al tempo.
In un’epoca segnata da crisi globali, guerre e minacce ambientali, il messaggio di Kiefer risuona con particolare forza. Se il mondo che conosciamo è destinato a cambiare, l’arte saprà trovare nuove forme per esistere, anche tra le macerie. Le rovine non sono mai la fine, ma sempre l’inizio di qualcos’altro.
Il libro di Kiefer è dunque un’opera che si colloca tra la teoria e la pratica, tra la riflessione intellettuale e l’esperienza diretta della materia. Non si limita a esporre un pensiero, ma lo incarna, lo trasforma in un oggetto che porta con sé le stesse tensioni e contraddizioni della sua poetica. Le pagine, così come le sue tele e installazioni, sembrano quasi soffrire il peso del tempo, accumulando strati di significati e di riferimenti che si intrecciano tra loro, creando un’opera aperta, destinata a essere riletta e reinterpretata a seconda del momento storico e della sensibilità del lettore.
In questa prospettiva, “L’arte sopravvivrà alle sue rovine” non è soltanto un libro su Kiefer, ma un libro di Kiefer, nel senso più profondo del termine. La sua scrittura, frammentaria e densa, sembra seguire la stessa logica compositiva delle sue opere: accumuli di pensiero che si sovrappongono, risonanze tra passato e presente, e una costante tensione tra il decadimento e la rinascita. Non c’è un punto di arrivo definitivo, né una verità assoluta da affermare: tutto è in movimento, tutto è instabile, come le macerie su cui l’artista lavora.
L’opera di Kiefer ha sempre suscitato reazioni contrastanti, proprio perché si muove su un crinale pericoloso: da un lato, il rischio della monumentalità, della retorica del passato che si impone con troppa forza; dall’altro, la capacità di trasformare la rovina in una materia viva, pulsante, che ci interroga nel presente. Questo libro si inserisce perfettamente in questa ambivalenza, offrendo una riflessione che non si limita a celebrare la resistenza dell’arte, ma che ci costringe a interrogarci sul senso stesso della memoria e della distruzione.
Dopotutto, Kiefer ci insegna che l’arte non è mai un monumento immobile, ma un campo di battaglia, un luogo di conflitto tra l’oblio e la sopravvivenza. Le sue rovine non sono mai solo rovine, ma frammenti di qualcosa che può ancora essere detto, ricostruito, reinventato. In questo senso, “L’arte sopravvivrà alle sue rovine” non è soltanto un titolo, ma un’affermazione che si fa opera: la prova vivente che, anche di fronte alla distruzione, qualcosa di nuovo può sempre emergere.
Questa dialettica tra distruzione e creazione, tra rovina e rinascita, attraversa l’intera opera di Kiefer, rendendo il suo lavoro una sorta di archeologia del presente, dove ogni traccia del passato non è mai pura reliquia, ma materia in divenire. Non si tratta solo di conservare ciò che è stato, ma di trasformarlo, di farlo parlare con nuove voci, di riscriverlo senza cancellarne le ferite. È questo che rende il suo linguaggio così potente: un’arte che non si accontenta di commemorare, ma che si sporca le mani con il tempo, che lavora la memoria come fosse piombo fuso, cenere o carta bruciata.
Nel libro, questa visione si articola attraverso un dialogo con la filosofia, la letteratura, la storia dell’arte, ma anche con la stessa materia di cui l’arte è fatta. Le parole di Kiefer si intrecciano con le immagini, creando un testo che non è mai del tutto spiegabile o lineare, ma che invita a essere attraversato, esplorato, letto come si leggerebbe un paesaggio dopo una tempesta. È una scrittura che sembra avere la stessa fisicità delle sue opere: densa, stratificata, a volte oscura, a volte luminosa, sempre in bilico tra il peso del passato e l’ansia del futuro.
Forse è proprio questa la lezione più profonda di “L’arte sopravvivrà alle sue rovine”: la consapevolezza che l’arte non è solo una risposta alla distruzione, ma anche un modo di abitarla, di darle forma senza negarla. Kiefer ci mostra che non esiste una separazione netta tra ciò che crolla e ciò che nasce, perché ogni rovina è già il primo passo verso una nuova costruzione. L’arte, nella sua visione, non è mai pura celebrazione, né semplice denuncia, ma un processo continuo di trasformazione, un dialogo incessante con il tempo e con la storia.
Alla fine, resta la sensazione che questo libro sia esso stesso un’opera aperta, un frammento destinato a essere riletto, rielaborato, forse persino dimenticato e poi riscoperto. Come le rovine che tanto affascinano Kiefer, anche le sue parole sembrano fatte per resistere, non come qualcosa di immobile, ma come qualcosa che cambia con chi le osserva. E in questo continuo gioco di memoria e oblio, distruzione e rinascita, Kiefer ci lascia un messaggio tanto semplice quanto radicale: finché esisterà qualcuno capace di guardare, di leggere, di interpretare, l’arte continuerà a vivere.
E forse, proprio per questo, l’arte è l’unica vera immortalità che abbiamo.
(15 febbraio 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata