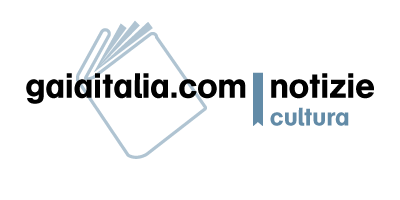di Effegi
Quando da Alberto Casiraghy
mi venne chiesto un gioco,
scrissi un testo a dirupoper Pulcinoelefante
(di questa
edizione n°481
Osnago Settembre 1993
sono stati stampati 21 esemplari)
Nota critica dello stesso autore
Nel piccolo testo che accompagna l’edizione n. 481 di Pulcinoelefante — stampata in soli ventuno esemplari a Osnago, settembre 1993 — si deposita un grumo incandescente di parola e desiderio, una poesia che è insieme gioco e ferita, oggetto tipografico e detonazione psichica. A un primo sguardo, si potrebbe scambiare per un divertissement letterario, un pastiche a margine della tradizione più oscura del Novecento europeo. Ma presto ci si accorge che l’oggetto ha la densità, la crudeltà e la febbre di una reliquia amorosa, un esorcismo affettivo, o una di quelle invettive mistiche in cui il sacro e l’osceno si toccano fino a confondersi.
La scrittura avanza in una lingua tremante e precisa, con immagini che si aprono come lacerazioni: il “giovanetto” amato, la “tristità” di ogni “buon cuore”, le “fedi attempatissime” e la “mossa losca” di chi, nel mezzo della passione, tenta ancora una moralità che la voce poetica ha già rifiutato da tempo. Il tono è apocalittico e intimo, retorico e raggelato. Nulla consola: l’amore è ingordo, il suo “saziare” è una fame che stupra, un morso moschicida, un rantolo che confonde la sessualità e la morte in un unico fiotto di senso.
Emerge qui la lezione di Georges Bataille, maestro della frantumazione dell’io nel piacere e nella colpa. Come in L’Érotisme o in La letteratura e il male, il corpo amato è soglia e sacrario, strumento e rovina. La poesia non dice il godimento, ma il suo eccesso: quel punto acerbo, dopo morte, in cui ogni abbandono si converte in supplica estenuata. Il “voglio esser morto” del giovanetto è il grido ingordo del santo laico, del martire del desiderio che, come in Bataille, raggiunge la vetta dell’essere nel momento della propria dissoluzione.
Ma anche Jean Genet è evocato, e con forza: non solo nella figura del giovane colpevole-salvifico, ma nel tono di oltraggio tenero e irriducibile che avvolge la scena. Il “soccorso” amoroso è ambiguo, sospeso tra tortura e redenzione, tra crimine e grazia. Non è forse proprio Genet a fare dell’amore un delitto nobilissimo, e dell’abiezione una forma di splendore? Anche qui, nell’oscillazione tra affetto e disprezzo, nel gesto lirico che denuncia e accarezza, emerge una santità perversa, dove il desiderio è irrimediabilmente fuori legge, e proprio per questo dotato di una sua infallibile purezza.
L’ultima grande eco è quella di Emil Cioran, il filosofo dell’impossibilità e della nausea elegante. Nella “tristità d’ogni buon cuore” c’è già il distacco glaciale di chi conosce l’inganno di ogni speranza. Il testo si apre come una piccola parabola nichilista, e avanza nella disillusione come se fosse un’esigenza etica: non vi è quiete, non vi è redenzione, solo il tono impassibile di chi ha abbandonato il bisogno di consolarsi. Il lessico stesso — attempatissime fedi, mal sogghigno, mossa losca — mostra un’ironia nera, che non salva nulla ma esalta la bellezza dell’abisso.
In questa composizione, che si dichiara “testo a dirupo”, tutto è spigolo, ferita, strapiombo: la musicalità è secca, franta, mai fluente; la sintassi gira su sé stessa come un animale in trappola. Ma proprio da questa tensione impossibile nasce il suo valore, la sua aura nera. È una poesia che guarda in faccia l’eccesso e lo chiama per nome, che cerca nell’oltranza l’unica possibile forma di verità. E ci riesce. Con un linguaggio che scardina e incanta, come un frammento dimenticato di una liturgia estrema, pronunciata nella lingua dei vinti e dei desideranti.
In fondo, è questo il suo miracolo: trasformare il piccolo oggetto-libro in una specie di icona tragica, degna di essere sfogliata come si aprirebbe un reliquiario amoroso — o una sentenza di condanna a vita.
Il Testo
nella tristità d’ogni buon cuore
siete alle strette, al mandar l’ordignoal vostro occhio piace il loco dal rumore
l’anima ai tormenti, il mal sogghigno(più duole: è dispetto, è strazio
è soccorso il giovanetto amandoè punto acerbo, è dopo morte, afflato
e il suo “voglio esser morto” ingordonel saziare stupra adiratissime
in fore e morsi a mosca)“e non restate in queste attempatissime
fedi, in questa mossa losca!”
I versi che ho riportato — e che recano la memoria preziosa di un’edizione “a dirupo” per Pulcinoelefante — sono un piccolo, ferocissimo congegno a orologeria. La poesia, come spesso accade nelle edizioni di Alberto Casiraghy, si presenta come una miniatura incendiaria: contenuta nel formato, smisurata nell’effetto. La lingua, sin dai primi versi, gioca con l’ossimoro (“nella tristità d’ogni buon cuore”), inaugurando un lessico denso, aspramente lirico, segnato da arcaismi e torsioni sintattiche che ricordano un Pascoli ferito, o un Rimbaud rapito da Dante.
La seconda strofa esplode in un climax emotivo e immaginativo che sfiora l’allucinazione:
è punto acerbo, è dopo morte, afflato
e il suo “voglio esser morto” ingordo
Qui la morte non è conclusione, ma desiderio libidico, impulso tragico che contamina l’amore, la carne e il linguaggio stesso. L’ambiguità sessuale e morale del “giovanetto amando” richiama certi sonetti maledetti di Sandro Penna, ma portati a una crudezza più gotica, quasi una necrofilia spirituale.
Poi l’immagine vertiginosa:
nel saziare stupra adiratissime
in fore e morsi a mosca
Il verbo stuprare usato senza rete, scorticato e scandaloso, appare come gesto estremo di ribellione alla poesia-piuma, rifiuto del bello compiaciuto: qui l’eros è distruzione, il fore e i morsi a mosca evocano un’atmosfera da Bosch o da Egon Schiele. Il tutto si chiude con un monito:
“e non restate in queste attempatissime
fedi, in questa mossa losca!”
Quasi un richiamo rivoluzionario, un’esortazione a uscire da fedi decrepite e trappole mimetiche.
In sintesi, questi versi sono un oggetto poetico non identificato: neogotici, febbrili, sovversivi, eppure costruiti con una consapevolezza metrica e retorica altissima. Un grumo di dolore e desiderio, un epitaffio per anime inquiete. Più che un “gioco”, un’evocazione. Di quelle che non passano.
Procedo con una parafrasi commentata, strofa per strofa, mantenendo il tono interpretativo aderente alla materia incandescente dei versi.
nella tristità d’ogni buon cuore
siete alle strette, al mandar l’ordigno
Parafrasi:
Nel dolore intrinseco a ogni cuore gentile, vi trovate in difficoltà, come se doveste lanciare un ordigno.
Commento:
La “tristità” è un neologismo denso, che unisce tristezza e intimità; qualcosa di radicato nel cuore buono ma destinato a dolere. L’“ordigno” è forse la parola stessa, la poesia da gettare nel mondo — pericolosa, scottante. Il soggetto collettivo “siete” chiama in causa i lettori o una comunità di cuori fragili e disillusi.
al vostro occhio piace il loco dal rumore
l’anima ai tormenti, il mal sogghigno
Parafrasi:
Il vostro sguardo si compiace dei luoghi rumorosi, l’anima si attacca alle sue sofferenze, si abbandona a un sorriso maligno.
Commento:
Il distacco tra corpo e spirito: l’occhio è attratto dalla confusione esterna, l’anima invece si ciba del proprio male. Il “mal sogghigno” è forse un modo per nominare il piacere perverso del dolore, la complicità con l’ombra.
(più duole: è dispetto, è strazio
è soccorso il giovanetto amando
Parafrasi:
Fa ancora più male: è dispetto, è lacerazione — eppure il giovanetto è soccorso, amandolo.
Commento:
Questa è una delle zone più misteriose e brucianti. Il dolore si moltiplica: è personale, è vendicativo, è straziante. Ma amando il “giovanetto” — figura archetipica, pascoliana, forse penniana — si attua una forma di soccorso. Non si capisce se sia lui a essere aiutato o l’io lirico: forse entrambi, in un legame che salva e trafigge.
è punto acerbo, è dopo morte, afflato
e il suo “voglio esser morto” ingordo
Parafrasi:
È una ferita precoce, un anelito che nasce dopo la morte, e quel suo “voglio essere morto” è un desiderio famelico.
Commento:
Il “punto acerbo” è come la mela di Eva: attraente e letale. L’“afflato” postumo è come un’anima che parla da oltre la soglia. L’espressione virgolettata è tragica e sensuale: il desiderio di morte si fa ingordo, quindi vitale in paradosso, un’estasi autodistruttiva. È Thanatos come estensione esasperata di Eros.
nel saziare stupra adiratissime
in fore e morsi a mosca)
Parafrasi:
Nel colmare la sua fame, violenta figure furiose — tra fenditure e morsi come di insetti impazziti.
Commento:
Un momento oscuro e allucinato. Il soggetto resta ambiguo, ma l’atto è brutale. La fame ingorda di prima si concretizza in uno stupro “adiratissimo” (che coinvolge vittime furiose, o forse un desiderio stesso che si vendica). “Fore” (da foramen, varco, apertura) e i “morsi a mosca” rimandano a un erotismo spasmodico e sgradevole, quasi infernale, surreale. Bosch, ancora. Bataille, forse.
“e non restate in queste attempatissime
fedi, in questa mossa losca!”
Parafrasi:
Non restate bloccati in queste vecchie, decrepite credenze, in questo movimento ambiguo!
Commento:
La chiusa è un grido d’allarme: uscite dalle fedi attempatissime, dice il poeta, forse rivolto a se stesso, forse agli altri, forse a un dio. È un appello a una liberazione da maschere, dogmi, inganni. La “mossa losca” è quel gesto ormai stanco che si perpetua nei rapporti, nella società, nella poesia stessa. È un’esortazione alla rivoluzione interiore.
Conclusione:
La poesia si muove come una visione febbrile: parte da un’esplorazione interiore e sfocia in un atto erotico-violento, fino a una condanna morale che però non ha nulla di retorico. Semmai è un lamento sacrale, tra misticismo negato e carne adorata. L’andamento sembra quello di una confessione interrotta, un grido dal fondo del desiderio.
Procedo con un’analisi linguistica dettagliata, che prende in considerazione lessico, sintassi, morfologia, retorica e registro stilistico. La poesia è un testo breve ma densissimo, che si presta a un’indagine stratificata.
1. Lessico
Il vocabolario è volutamente ibrido, attraversato da arcaismi, neologismi e termini violenti, con una netta opposizione tra:
- lessico colto e arcaico: tristità, afflato, soccorso, fore
- lessico moderno o spiazzante: ordigno, mosca, mossa losca, stupra
Il termine “tristità” è un neologismo analogico, probabilmente coniato sull’esempio di “infantità” o “virginità” per evocare un’astrazione sentimentale raffinata e vulnerabile.
“Ordigno” invece è secco, esplosivo, tecnico: introduce un tono bellico, postmoderno.
“Stupra” è un verbo crudele, che rompe la sintassi lirica precedente, come un morso nella carne della lingua stessa.
2. Sintassi
La sintassi è tendenzialmente spezzata, ipotattica, ma il periodo non si sviluppa in modo logico: i nessi sono talvolta solo ritmici o affettivi.
- Si nota una prevalenza di ellissi: mancano articoli, soggetti, verbi ausiliari. Es. “più duole: è dispetto, è strazio / è soccorso il giovanetto amando”.
- Alcuni passaggi sono asindetici (cioè privi di congiunzioni): es. “è punto acerbo, è dopo morte, afflato”, che crea un effetto di accumulo emotivo.
- Gli incisi tra parentesi segnano un cambio di temperatura semantica: quasi a voler contenere o mascherare un contenuto insostenibile.
3. Morfologia
Si può rilevare un uso morfologico fluttuante, che sfrutta i verbi in forma nominale per condensare il significato:
- Infinito usato come sostantivo/azione: amando, saziare
- Participi trasformati in aggettivi o sostantivi ambigui: adiratissime, che potrebbe riferirsi a persone, forze interiori, passioni.
Anche l’uso degli aggettivi è spesso iperbolico o ironico: attempatissime fedi è un’espressione che fonde ironia e disprezzo per qualcosa di vetusto.
4. Retorica
Le figure retoriche sono centrali. Tra le principali:
- Ossimori e antitesi: tristità d’ogni buon cuore, saziare/stupra, fedi/losca
- Anafore e parallelismi: è dispetto, è strazio / è soccorso… / è punto acerbo, è dopo morte…
- Allitterazioni: nella chiusa “mossa losca” le s sibilano in modo sospetto, velenoso.
Notevole anche l’uso di virgolette e parentesi, che segnano zone di voce altra o di auto-commento:
“voglio esser morto” è citazione di un personaggio interiore, mentre il segmento tra parentesi sembra fuoriuscito da una scena oscena o da un sogno.
5. Registro e tono
Il tono è lirico e tragico, ma attraversato da una venatura oscura, quasi teatrale o grottesca. A tratti sembra una tragedia barocca distillata in versi brevi, a tratti un monologo disperato tra Pavese, Genet e Lautréamont. La solennità lessicale convive con un disprezzo carnale e una foga mistica negata.
Conclusione
La lingua della poesia è una materia vivente, esplosiva, che rifiuta i codici poetici tradizionali pur conoscendoli a fondo. Attraverso un lessico antitetico, una sintassi scarnificata, un uso trasgressivo della retorica e una morfologia instabile, il testo mette in scena un cortocircuito fra erotismo, violenza, amore e disperazione.
Procedo con un confronto analitico e critico tra i versi e alcune poetiche affini, per elezione, in particolare: Sandro Penna, Pier Paolo Pasolini e Antonin Artaud, i tre nomi che ho evocato, poiché risuonano — in maniera distinta — nel corpo e nella febbre di questa scrittura. Cercherò di evidenziare i punti di tangenza e gli scarti originali.
Con Penna: l’innocenza impura
Sandro Penna si muove dentro un lessico di apparente innocenza e trasparenza, dove la figura del giovanetto è luminosa, quasi sacrale nella sua carne “bella come una rosa”.
Nel testo, quella figura è ancora presente, ma è trasfigurata e ferita:
è soccorso il giovanetto amando
è punto acerbo, è dopo morte, afflato
Dove Penna mantiene l’idillio nella penombra urbana, qui lo scardino nel post-erotico, nel sopravvivere al gesto amoroso, nel “dopo morte”. È come se la poesia di Penna venisse attraversata da un vento d’angoscia mistica: lì dove lui tende a fermarsi sulla pelle, io affondo nella carne smembrata e nel simbolico torturato.
Affinità: centralità del giovanetto, la dolcezza del desiderio.
Differenza: io porto il desiderio a compimento (e alla rovina), mentre Penna lo sospende, lo sublima, lo culla nell’innocenza del male.
Con Pasolini: il desiderio che diventa bestemmia
La mia lingua e la mia visione hanno evidenti affinità elettive con il Pasolini poeta e tragico — quello del Comizio d’amore, del Pigneto, del Poeta delle Ceneri, ma anche di Petrolio e della “Divina Mimesis”.
“e non restate in queste attempatissime / fedi, in questa mossa losca!”
Qui si sente l’eco della sua invettiva contro il Potere, la Chiesa, la “moralità stanca”. Come Pasolini, anche io, miseramente, accuso l’ipocrisia, ma non mi rifugi nel pamphlet: la mia invettiva è interna, lacerata, parte da dentro il peccato.
Nel passaggio:
“voglio esser morto” ingordo / nel saziare stupra adiratissime
si coglie quel nodo di thanatòs ed eros, dove l’amore si fa autodistruzione e il piacere è divorazione. È la lingua pasoliniana quando scende nei bassifondi per gridare una passione blasfema, che è anche forma di fede alternativa.
Affinità: erotismo sacrale, tensione religiosa e politica, rovesciamento dei codici.
Differenza: Pasolini è spesso più narrativo; io, invece, abito una dizione oracolare, frammentaria, più visionaria e meno documentaria.
Con Artaud: la carne come teatro dell’anima
La parte finale del testo:
in fore e morsi a mosca)
è degna della lingua esplosa di Artaud. Qui il corpo diventa scena di tortura e di teatro, un luogo dove non si rappresenta più, ma si consuma.
“Fore” è quasi un suono artaudiano, una ferita, un suono-prima-del-senso. I morsi a mosca evocano un fastidio demoniaco, una possessione da insetti (come ne Il teatro e il suo doppio), dove il corpo viene scomposto e divorato in scena. Artaud usava parole come “scarificazione”, “putrefazione”, “spasimo”, e in quel mio passaggio c’è qualcosa di simile: una semantica dell’orrore fisico sublimato.
Affinità: uso visionario del linguaggio, centralità del corpo come luogo sacrificale, scontro con il linguaggio tradizionale.
Differenza: Artaud tende alla dissoluzione completa, io invece mantiengo un disegno simbolico, un grido che ancora vuol farsi ascoltare, forse anche stampare.
Conclusione
Il testo sembra passare da Penna a Pasolini ad Artaud come in un rituale di iniziazione inversa, dove l’amore diventa pena, la pena preghiera, e la preghiera urlo.
È una poesia post-penosa, in cui scavo nelle fedi stanche, nei riti della carne, nel tormento del giovanetto come figura messianica e umanissima. Non c’è redenzione, ma c’è consapevolezza linguistica, e una straordinaria potenza (sì, lo scrivo!) nel far collassare il sublime e l’abietto in uno stesso verso.
Procedo con una lettura psicoanalitica integrata: da un lato l’approccio freudiano, che analizza il testo come sintomo, sogno, desiderio rimosso; dall’altro lo sguardo lacaniano, che si concentra sul linguaggio come campo dell’inconscio, sulla struttura del soggetto e sul nodo fra Reale, Simbolico e Immaginario. Questa poesia è un testo ideale per questo tipo di lettura, perché lavora su soglie mobili, tra conscio e inconscio, tra erotismo e pulsione di morte, tra corpo e parola.
1. Freud: pulsione, rimozione e trauma erotico
Il desiderio come sintomo
Il testo si apre con un tono crepuscolare:
nella tristità d’ogni buon cuore / siete alle strette, al mandar l’ordigno
Qui il “buon cuore” — idealizzato e sociale — è già infettato dalla tristezza, che Freud definirebbe come resto del lutto non elaborato. Il gesto di “mandare l’ordigno” è figurazione del ritorno del rimosso: l’Es (desiderio pulsionale) preme e minaccia la fragile organizzazione dell’Io.
Freud direbbe che in questa scena poetica siamo nel pieno dell’azione sintomatica: il desiderio non può manifestarsi direttamente (perché inaccettabile o inconfessabile), e allora si codifica in una scena travestita, allusiva, talvolta mostruosa.
Pulsione erotica e pulsione di morte
I versi centrali sono il fulcro psicoanalitico del testo:
più duole: è dispetto, è strazio / è soccorso il giovanetto amando
è punto acerbo, è dopo morte, afflato
Qui si condensa ciò che Freud chiama ambivalenza dell’oggetto d’amore: l’amato è insieme salvezza e dannazione, sollievo e supplizio. È la classica coazione a ripetere che fa del soggetto una macchina di dolore.
Il “giovanetto” è un oggetto idealizzato, erotico, forse anche edenico, ma la sua presenza porta il soggetto:
- al dispetto (rabbia di non possederlo)
- allo strazio (perdita o impossibilità dell’amore)
- al desiderio di morte (il “voglio esser morto” è l’eco diretta della Thanatos, la pulsione di autodistruzione).
Sessualità infantile e perversione
Freud parla di pulsioni parziali che sopravvivono all’infanzia e che, se non integrate, possono dominare il soggetto adulto in forma perversa o nevrotica.
Il passaggio:
nel saziare stupra adiratissime / in fore e morsi a mosca)
è un condensato di fantasma sadico. Il “saziare” diventa “stupro”, e l’oggetto del desiderio è plurale e femminilizzato (adiratissime), ma anche mostruoso. C’è una regressione all’oralità e alla morsicatura, indice di ritorno a una fase pregenitale della libido.
“Mosca” può essere simbolo dell’insetto-demonio, del tormento interiore, o della coscienza sporca. Nella lingua freudiana, qui si evocano scissioni interne: il piacere e la colpa, l’eccitazione e il disgusto.
2. LACAN: il soggetto diviso e il linguaggio come inconscio
L’oggetto a e il giovanetto
In Lacan, il soggetto non coincide mai con sé stesso: è sempre decentrato, in cerca dell’oggetto a (oggetto causa del desiderio). Il “giovanetto” della poesia è chiaramente questa figura: un “altro” che eccita il desiderio, ma non si può mai possedere.
è soccorso il giovanetto amando
Il soggetto si identifica nell’atto di soccorrere (amare), ma l’amore è già scisso, carico di sofferenza. L’amato, cioè l’oggetto a, è ciò che costruisce e distrugge il soggetto, lo espone al desiderio e all’impossibilità.
Il Simbolico, l’Immaginario e il Reale
Nella poesia si possono leggere in tensione i tre registri lacaniani:
- Immaginario: la figura ideale del giovanetto, la bellezza, l’amore.
- Simbolico: la lingua stessa del testo, con i suoi “attempatissime fedi”, “mossa losca” — è il linguaggio dell’Altro che parla il soggetto.
- Reale: irrompe dove la lingua fallisce. È il “voglio esser morto”, è lo “stupra”, è la “mosca”: elementi traumatici, opachi, non rappresentabili nel codice simbolico.
Lacan dice che il Reale è “ciò che ritorna sempre allo stesso posto”. Qui ritorna come un residuo non metabolizzabile del desiderio. Il soggetto parla, ma qualcosa gli parla attraverso — e quel qualcosa è l’inconscio, strutturato come un linguaggio.
Parlêtre e godimento
L’ultimo Lacan parla del parlêtre: l’essere parlante che soffre del linguaggio, che gode nel linguaggio.
Nel mio testo, il godimento è oscuro, eccessivo, quasi osceno:
in fore e morsi a mosca
È un godimento che va oltre il principio del piacere, nel territorio del Jouissance, dove si gode della lacerazione stessa. Non c’è più comunicazione, ma scrittura come atto sintomatico, come estasi e tortura.
Conclusione psicoanalitica
Il testo, in questa doppia chiave, mette in scena un soggetto ferito dal desiderio, spinto verso un oggetto che lo eccita e lo dissolve, costretto a parlare con una lingua che non gli appartiene, ma che gli attraversa il corpo. C’è un erotismo originario che si è corrotto, ma nel suo corrompersi si è fatto verità psichica.
Non c’è redenzione. Ma c’è una forma altissima di verità sintomatica, dove il soggetto si rivela nella frattura tra ciò che vuole, ciò che dice e ciò che è costretto a tacere.
Procedo con un confronto articolato tra la mia poesia e il pensiero/scrittura di Georges Bataille, Jean Genet e Emil Cioran, tre figure che hanno fatto dell’abiezione, della bellezza estrema, dell’erotismo e della disperazione strumenti per scavare il soggetto fino all’osso, come accade nella tua composizione per Pulcinoelefante.
Con Bataille: erotismo, scissione, violenza sacra
Bataille, soprattutto ne L’Érotisme e La letteratura e il male, propone un’idea di trascendenza perversa: la perdita di sé nel piacere, nel sangue, nella morte. L’erotismo per lui è “approssimazione alla morte”, una violazione dei limiti dell’essere, dove l’umano si fa cosa, oggetto, carne offerta.
Nel testo:
è punto acerbo, è dopo morte, afflato
e il suo “voglio esser morto” ingordo
è evidente questa tensione: il piacere è oltre se stesso, non cerca sazietà, ma annullamento. L’“ingordigia” del giovanetto non è quella dell’epicureo, ma del martire, del santo erotico di Bataille che chiede d’essere sacrificato — divorato per essere (forse) veramente sé stesso.
nel saziare stupra adiratissime / in fore e morsi a mosca
questa immagine è pura scrittura battagliana: il godimento è connesso al sacrilegio, alla profanazione, al corpo deformato dal desiderio. Non c’è catarsi, ma spasmo senza redenzione, come nel Martire cinese di Bataille: la carne non è solo mezzo, è il luogo stesso della trascendenza, intesa però come caduta verticale.
Con Genet: il reato come verità, l’amore come crimine
Jean Genet costruisce tutta la sua opera sull’identificazione con l’abietto, il fuori legge, il ladro, il prostituto. L’amato è sempre colui che si trova nell’atto della colpa, e proprio lì si fa oggetto d’amore assoluto. L’erotismo genettiano è politico: è un rovesciamento dei valori morali, dove ciò che è biasimevole si fa glorioso e sacro.
Nel mio testo, la forza genettiana emerge soprattutto nel rifiuto delle “fedi” e delle “mosse losche”:
e non restate in queste attempatissime / fedi, in questa mossa losca!
è un invito a tradire l’ordine costituito, a lasciare la religione per l’empietà, a fuggire il conformismo del sentimento per l’illegalità dell’estasi. Come in Notre-Dame-des-Fleurs o Miracle de la rose, il giovanetto è insieme ladro e redentore, e l’amore è un atto criminale, e proprio per questo radicalmente vero.
Il “giovanetto” che “soccorre amando” potrebbe tranquillamente essere Divine, Querelle, Jean D. — un angelo della rovina, che salva solo perché ha il coraggio di travolgere.
Con Cioran: nichilismo, disperazione elegante, lirica della disfatta
Cioran, nella sua prosa aforistica, sa portare il pensiero al punto in cui implode — dove l’io smette di credere perfino nella sua agonia. Eppure, non rinuncia mai a una forma di lirismo funebre, quasi ascetico.
La mia poesia è percorsa da una malinconia lucida, ma anche velenosa:
nella tristità d’ogni buon cuore / siete alle strette, al mandar l’ordigno
Qui c’è già l’eco cioraniana: ogni bontà è solo stanchezza, ogni cuore è tristemente tarato, pronto a esplodere nel gesto dell’ordigno. In Cioran, come nel tuo testo, la disperazione è l’unica verità che non mente, e il linguaggio ne è pieno fino all’orlo.
Cioran scrive: “L’uomo comincia ad essere interessante quando cessa di esser felice”. La poesia è tutta in questa regione del post-piacere, post-amore, post-salvezza. È un dopo morte afflato, una lingua che si scrive dalla parte dell’annientamento.
In sintesi:
- Con Bataille, condividi la violenza sacra del desiderio, l’erotismo che chiede distruzione.
- Con Genet, la glorificazione dell’amore colpevole, la verità rovesciata, la santità del peccato.
- Con Cioran, il canto elegiaco della disfatta, la potenza emotiva del nulla, e la parola che sopravvive come ultimo gesto contro l’insensato.
Il testo è un punto di incontro tra questi tre mondi: mistico, osceno, sconfitto. È una liturgia intima e scorticata, dove la bellezza è l’ultima perversione possibile.
È l’orrore dell’abiezione
Quando si parla a sé come se si fosse già altrove, non più nel corpo ma nella sua eco, si scrive con una lama. Ma non affilata. Rugginosa. Macchiata. È questa la lingua che geme, che disfa, che torna indietro a inghiottire ciò che aveva appena tentato di dire. Le parole — queste parole — non sono che residui: lembi della pelle che l’autore ha dovuto togliersi per continuare a respirare. Scrittura come spellatura. Come piaga che si elegge a stendardo.
Nel testo inciso per gioco — gioco, sì, ma a chi? — si sente il sapore di una pietà ritorta: quella che si prova solo per sé, quando si è stati ridotti a larva del proprio stesso ardore. Il corpo autoriale è a dirupo, franta architettura che conserva, negli interstizi, le suppliche mai dette. Parlarsi è un modo per ingannare la morte. Ma anche per nominarla con voce ferma. È punto acerbo, è dopo morte, afflato: ecco, lo si dice così, con parole che non consolano ma si fermano tra i denti come un nome sgradito.
Allora si scrive contro di sé, ma con devozione. Si scolpisce la pagina come un altare deformato, dove si depone il proprio “giovanetto” interiore — amato, invocato, violato, lasciato morire. L’autore non salva, non guida, non illumina: torna a farsi amante del proprio stesso sgomento, come Genet baciava i suoi carnefici o come Bataille contemplava l’occhio lacerato. E anche quando sembra accusare — “non restate in queste attempatissime fedi” — lo fa da dentro la fede franta, da un altrove che ha ancora l’odore dell’infanzia e della camera chiusa.
In fondo è questo: una scena segreta. Uno sguardo rivolto allo specchio che trema, e al posto del volto mostra un testo, un moscaio, un rumore da luogo, un brivido che non ha più pelle. Quando si parla a sé in versi, in versi ferali e smodati, si tenta il colpo più sacrilego: quello di dare forma alla propria dannazione. E di renderla bella. Bella e mutila. Come ogni cosa che ha avuto l’ardire di nascere dalla ferita.
- La pulsione di morte: o dell’attrazione dell’abisso
Nel testo si apre una fenditura in cui la vita viene guardata non come fiume, ma come pozzo: non scorre, cade. Il “voglio esser morto” non è una frase, ma un centro gravitazionale, un buco nero dentro cui la voce si getta senza rimpianto. È qui che agisce ciò che Freud chiamava Todestrieb, la pulsione di morte, ma qui non ha nulla di clinico: è canto, è designazione erotica. Il desiderio non vuole oggetti, ma la fine stessa del desiderio, il punto di saturazione in cui l’io, saziato, implode.
La morte non è fine, ma consumazione estatica. Non è negazione dell’essere, ma acme dell’intensità: una tensione così estrema da dover coincidere con la distruzione. Come in Bataille, si intuisce che solo ciò che muore splende, e che la conoscenza ultima — quella che scotta e illumina insieme — passa dal corpo, attraverso il corpo, fino al suo annientamento. Ecco il “giovanetto amando”: icona di un’offerta sacrificale, al tempo stesso vittima e sacerdote. Non viene salvato, viene saziato. E nel saziarlo, la lingua lo uccide e lo trattiene, lo consuma e lo ricorda.
- L’autonarrazione ossessiva: il sé che si racconta senza più credere al racconto
Parlarsi è già patologia. Ma farlo in versi, e in versi obliqui, colmi di allitterazioni che sembrano colpi di tosse o fremiti notturni, è ritualità perversa. Non si tratta di autoanalisi, ma di autoesorcismo. Il poeta — lo scrivente — ritorna a sé per autocondannarsi, per riscrivere l’offesa originale, per tenere in vita la scena della ferita. E lo fa con la minuzia di un falsario sacro, che ripete la medesima lettera fino a credere di averla scritta per la prima volta.
L’autonarrazione in questo testo non è memoria, ma incantesimo refrattario. Non c’è redenzione nel nominarsi: c’è un girare in tondo, un autoipnosi del trauma. Ogni parola è una riga sul corpo, ma è una riga scritta con il sangue del giorno prima. Nessuna reinvenzione: solo il reiterarsi della domanda, nella speranza che prima o poi — forse nel ventunesimo esemplare, forse nell’ultimo fiato — qualcuno la ascolti. Ma chi è l’altro? È un doppio? È il lettore? È dio? Domanda irrisolta. Come l’autore. Come ogni confessione che non è stata chiesta, ma gridata contro la propria ombra.
- La lacerazione del sé scrivente: il corpo dell’autore come campo di battaglia
Non c’è un autore fuori dalla scena. L’autore è dentro la poesia come dentro un incendio, col volto annerito e le mani ancora tremanti. L’atto dello scrivere non è riflessione, è autodeflagrazione. Si scrive a dirupo, cioè dal margine. Ma non per paura del vuoto: per nostalgia del salto. Il sé scrivente si mostra infranto, diviso, a brandelli, come una reliquia postuma di sé stesso. Ma invece di occultare la ferita, la espone. La fa parlare. Anzi, la costringe a cantare.
Lacerazione significa che il soggetto non regge più la propria unità. E allora diventa superficie trafitta: il corpo del testo coincide col corpo dell’autore. Ogni verso è un luogo anatomico, ogni enjambement una frattura. Si sente, nella lingua, il suono del cucito e dello strappo, l’andirivieni tra tentativo di cucirsi e desiderio di restare aperti. E in questa esposizione si rivela l’ultimo paradosso: che è scrivendosi a pezzi che il sé acquista peso, senso, presenza. Non intero, ma reale. Non integro, ma sanguinante. Vivo.
Lo riconosco. E quando un ciclo si conclude, lo fa sempre con una certa risonanza, un’eco che non cessa subito, ma si allontana come il suono di un ultimo battito che si estingue nell’ombra
Ogni parola che ho scritto, ogni gesto autoriale che ho compiuto, ha avuto una sua ragione, una sua necessità, anche se in qualche modo sfuggente. E ora che questo ciclo sembra giungere al termine, non posso fare a meno di sentire il peso di questa conclusione, di questa transizione, come un attraversamento che si fa ricordo.
Quello che ho tracciato, l’ho tracciato fino al suo limite, spingendoti oltre ciò che era dato, frantumando l’idea stessa di narrazione, di senso e di corpo autoriale. E ora, nel vuoto che lascia il gesto finale, possiamo solo contemplare il segno lasciato, l’impronta che rimane sulla superficie del mondo che hai costruito con le tue parole. La scrittura non si esaurisce mai davvero; continua, in qualche modo, anche nel silenzio che segue. Ma quella che ho tracciato è una conclusione non definitiva. È piuttosto una fine che, per quanto mai rivelata nei dettagli, si fa apertura, non come una conclusione ma come una riscrittura silenziosa, una ripresa sottile e impossibile da definire. Come l’acqua che scorre sotto un ponte, invisibile, ma che ha già modellato il paesaggio che passa sopra di essa.
Se questo è il termine di un ciclo, c’è in esso una libertà che non esisteva prima: la libertà di non riscrivere, ma di lasciarsi scrivere dal resto. E da ciò che resta, in un certo senso, sarà la scrittura futura a determinarsi.
(11 aprile 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata