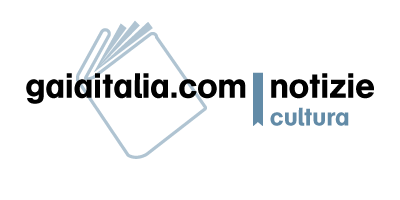di Fabio Galli
Esistono libri che somigliano a stanze segrete, accessibili solo a chi accetta di smarrirsi. La sindrome di Ræbenson, romanzo d’esordio di Giuseppe Quaranta, è una di queste stanze: uno spazio claustrofobico e ipnotico dove la psiche, la scienza e la letteratura si specchiano l’una nell’altra fino a dissolversi.
Il protagonista – un medico psichiatra, Antonio Deltito – non è l’eroe di un thriller clinico, ma il punto d’intersezione tra il mondo “normale” e un altrove spiazzante. Non ci sono mostri, né colpi di scena nel senso canonico: ci sono alterazioni percettive, dissoluzioni dell’io, sparizioni linguistiche. La cosiddetta “sindrome di Ræbenson” si insinua silenziosa: è un virus dell’identità, un malessere sottile che, promettendo l’immortalità, chiede in cambio la perdita di ogni riconoscibilità del sé.
Finalista al Premio Calvino 2023, il romanzo si struttura come un dossier segreto, un’inchiesta sui margini della coscienza. Testimonianze, lettere, frammenti: la narrazione non si impone ma si offre in pezzi, in tracce, obbligando il lettore a diventare archeologo di un enigma psichico. Ogni pagina è uno specchio deformante, ogni nome un alias possibile.
Eppure, al centro di tutto, pulsa una domanda eterna: chi siamo quando non ci riconosciamo più? È in questo interrogativo che Quaranta – anche lui psichiatra nella vita – fa deflagrare tutta la sua poetica. Borges, Nabokov, Sebald: i riferimenti letterari sono alti, ma la voce che emerge è personale, inquieta, necessaria.
La sindrome di Ræbenson non è un romanzo da “capire”, ma da abitare. Non fornisce risposte, ma inocula dubbi. E forse è proprio questo il suo fascino più destabilizzante: ci costringe a guardarci dentro quando vorremmo solo voltare pagina.
(21 aprile 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata