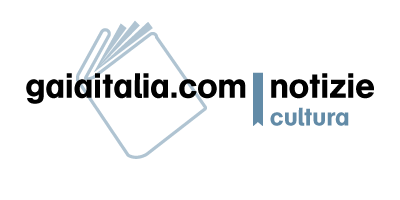di Fabio Galli
L’arte non è mai innocente. Anche quando si finge sussurrata, astratta, lirica, porta dentro di sé una forza che può edificare o distruggere. Fin dagli albori delle civiltà, ogni espressione visiva – dal trionfo scolpito sulla pietra al manifesto stampato in serie – ha potuto diventare un atto di potere. Parlare di “arte e propaganda” significa allora guardare non solo all’estetica, ma alla capacità dell’immagine di agire sul mondo, di influenzarlo, piegarlo, sedurlo, costringerlo a vedere (e a credere) qualcosa.
Se la propaganda è la messa in scena di un’ideologia, l’arte può esserne l’attrice principale, consenziente o costretta. Nei regimi totalitari del Novecento, questa simbiosi è stata portata all’estremo. Il fascismo italiano, per esempio, non si accontentò di un’arte che lo rappresentasse: volle un’arte che lo incarnasse, che desse forma all’idea di un nuovo Impero. Ecco allora le sculture marmoree degli atleti, i mosaici che evocano la gloria di Roma antica, le architetture razionaliste – fredde, solenni, muscolari – pensate per ispirare soggezione. Ogni opera doveva gridare “ordine”, “forza”, “disciplina”.
Ma non fu solo l’Italia. In Unione Sovietica, l’arte divenne una sorta di catechismo visivo: i quadri del realismo socialista mostravano contadini sorridenti e fabbriche radiose, madri eroiche e bambini che guardano verso il futuro. Era un mondo fittizio, imbellettato, ma costruito con tecniche spesso raffinatissime. L’intento era chiaro: non riflettere la realtà, bensì crearne una nuova, fondata sull’ideale comunista. L’artista diventava un ingranaggio della macchina rivoluzionaria.
La Germania nazista, invece, usò l’arte per purificare simbolicamente la razza. Mentre il regime bandiva l’“arte degenerata” – cioè l’arte d’avanguardia, astratta, inquieta – esaltava una figurazione idealizzata e iper-reale: paesaggi mitici, nudi ariani, famiglie bionde e sane. Nel 1937, la mostra “Entartete Kunst” (Arte degenerata) fu uno spettacolo mediatico: un’operazione di propaganda travestita da critica estetica, con lo scopo di umiliare gli artisti non conformi e allo stesso tempo rafforzare l’identità nazionale.
Ma la propaganda non ha colore unico. Anche le democrazie liberali hanno esercitato la loro influenza sull’immaginario. Durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti investirono ingenti risorse per promuovere la propria idea di libertà culturale. Mostre di Jackson Pollock e dei pittori dell’Espressionismo Astratto vennero esportate in Europa come simbolo della creatività “libera” dell’Occidente, contrapposta al dogmatismo sovietico. Era una guerra tra pennelli, ma dietro c’erano la CIA e le logiche geopolitiche.
La pop art, più tardi, diventa essa stessa una forma di propaganda, ma stavolta in forma di specchio deformante. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist – tutti a loro modo – utilizzano il linguaggio della pubblicità, dei fumetti, del consumismo per metterli sotto i riflettori, amplificarli fino al grottesco. È una propaganda che si mima e si sabota, che seduce con la stessa arma con cui denuncia. E qui si apre un’altra dimensione del rapporto tra arte e propaganda: quella ambigua, fluida, ironica, dove l’artista non obbedisce, ma si appropria del linguaggio del potere per smascherarlo.
Parallelamente, l’arte del dissenso, dai manifesti del Sessantotto ai murales zapatisti, dal femminismo visivo degli anni ’70 alle performance queer contemporanee, rovescia la logica propagandistica: non più “convincere” per conto di uno Stato o di un’ideologia, ma sovvertire la narrazione dominante, dare voce a ciò che è marginale, rifiutato, stigmatizzato. In questo senso, la propaganda si fa strumento anche dell’opposizione, dell’autodeterminazione, della rivolta.
Un caso emblematico è quello dei murales di Diego Rivera in Messico. Commissionati dallo Stato post-rivoluzionario, sono allo stesso tempo celebrazioni epiche del popolo e manifeste ideologici del marxismo. Rivera riesce a fondere il linguaggio monumentale – proprio della propaganda – con una poetica profondamente personale. I suoi affreschi non sono neutri: sono costruzioni di memoria e futuro, insegnamenti per chi guarda. Eppure, dentro la retorica, pulsa un pathos autentico, una volontà di bellezza che non si lascia ridurre all’utilità.
Lo stesso si potrebbe dire per le fotografie di propaganda bellica, dalle immagini di Dorothea Lange negli Stati Uniti durante il New Deal, ai capolavori di Evgenij Chaldej nell’Unione Sovietica. Fotografie che dovevano “dire qualcosa”, e che a volte – nonostante il filtro ideologico – riescono a conservare un’irriducibile verità umana. Il volto della fame, della fatica, della vittoria, della perdita.
E che dire del cinema? Nessun altro mezzo è stato così potentemente usato per la propaganda. Triumph des Willens di Leni Riefenstahl, realizzato per glorificare Hitler, è ancora oggi un capolavoro tecnico che solleva domande imbarazzanti: si può separare la forma dal contenuto? L’estetica dalla morale? E dove si collocano le immagini della Resistenza, o i film hollywoodiani usati per sostenere l’intervento americano durante la Seconda guerra mondiale?
Oggi, nell’epoca dei social media e della comunicazione istantanea, l’arte di propaganda non è scomparsa: ha solo cambiato forma. I meme politici, le grafiche delle campagne elettorali, le performance virali, le opere visive usate per campagne umanitarie o ideologiche: tutto contribuisce a costruire una nuova estetica della persuasione. Ma la differenza è che oggi, spesso, siamo noi stessi – artisti, utenti, spettatori – a scegliere i nostri strumenti di propaganda, a manipolarli, a farci testimoni e creatori.
Danza: il corpo come manifesto
Partiamo dalla danza, da quel gesto che sembra ancestrale, primordiale, lontano da ogni calcolo ideologico. E invece il corpo è spesso il primo campo di battaglia della propaganda: è lì che si scrivono le gerarchie, le norme, le narrazioni del potere. Nella Russia sovietica, il balletto di Stato non era solo spettacolo: era la coreografia del socialismo. Le ballerine, eteree ma disciplinatissime, incarnavano la grazia che nasceva dalla fatica collettiva. La Bayadère, La fonte della Bakčisaraj, Giselle – adattate e riscritte per conformarsi all’ethos comunista – raccontavano storie “universali” ma infuse di ideologia. Persino il passo, la postura, la simmetria dei movimenti erano espressione del principio ordinatore del regime.
Ma il controllo sul corpo danzante è stato esercitato ovunque: nel Terzo Reich, i balletti di Mary Wigman venivano celebrati come espressioni dell’anima tedesca, della purezza razziale, della connessione mistica con la terra. In Italia, sotto il fascismo, si tentò di creare una “danza nazionale” opposta all’americanismo e ai ritmi “degenerati” del jazz. La danza folklorica fu imbalsamata in spettacoli propagandistici in cui il costume tradizionale diventava divisa ideologica.
Eppure, la danza è anche luogo di sovversione. Negli anni Settanta, le coreografie di Pina Bausch scardinano la linearità narrativa, smontano la bellezza codificata e introducono corpi vulnerabili, isterici, dissonanti. Negli anni Ottanta e Novanta, le culture underground – dal voguing delle ballroom queer afroamericane al butoh giapponese – offrono forme alternative di rappresentazione, corpi dissidenti, movimenti che non cercano approvazione, ma creano comunità, riscrivono identità, sfidano il visibile. È una contro-propaganda gestuale, una grammatica della resistenza che passa per l’osceno, l’eccesso, la scompostezza.
Musica: l’emozione come veicolo ideologico
La musica è probabilmente il veicolo più potente della propaganda, perché scavalca la razionalità. È immediata, penetrante, totalizzante. Nell’epoca moderna, nessun regime ha trascurato il suo potenziale. Gli inni, le marce, i cori popolari – da La Marsigliese a Giovinezza, da L’Internazionale ai canti fascisti – sono strumenti di coesione ma anche di dominio. Il suono produce appartenenza: è una forma di possesso affettivo.
Nel Novecento, molti compositori hanno vissuto sulla soglia dell’ambiguità tra genio artistico e compromissione ideologica. Richard Strauss fu presidente della Camera della Musica del Reich; Carl Orff compose Carmina Burana in una Germania che desiderava nuovi miti arcaici e collettivi. Dall’altra parte dell’oceano, le composizioni jazz e blues, inizialmente stigmatizzate come “barbare” o “licenziose”, furono progressivamente cooptate per promuovere l’immagine di una società americana aperta, libera, tollerante – immagine falsa, ma propagandisticamente efficace durante la Guerra Fredda.
La contro-propaganda musicale esplode con la canzone d’autore e il folk militante. Bob Dylan, Phil Ochs, Victor Jara, Mercedes Sosa – le loro voci non si limitavano a raccontare, ma a mobilitare, a scuotere, a creare un linguaggio comune. In Italia, i cantautori come De André, Guccini, Lolli, Jannacci hanno fatto del racconto una forma di risveglio politico, non gridato ma radicale. E nella disco music, apparentemente apolitica, si nascondeva un’energia liberatoria che era in sé un atto di rivolta: pensiamo a Sylvester, ai Village People, a Donna Summer. In pista si celebrava il diritto all’euforia, al corpo, al desiderio. Una gioia che diventava visione del mondo.
Teatro: ideologia in scena
Il teatro è stato – e resta – uno dei luoghi più direttamente investiti dalla propaganda, perché unisce parola, gesto, sguardo, presenza fisica. Il teatro greco classico era in sé un dispositivo civico: le tragedie di Eschilo, Sofocle, Euripide non erano solo racconti mitici, ma riflessioni collettive su giustizia, legge, vendetta, potere. Anche Shakespeare, in piena età elisabettiana, scriveva sotto l’occhio vigile del potere monarchico. Le sue tragedie storiche costruivano un pantheon nazionale.
Nel Novecento, il teatro si politicizza in forma esplicita. Piscator coniuga Marx e scena, proiettando numeri, grafici, titoli di giornale sul fondale per spezzare l’illusione teatrale e risvegliare la coscienza. Brecht, con la sua opera da tre soldi o Madre Courage, non vuole far piangere ma pensare. La propaganda qui si trasforma in pedagogia critica, in distacco, in consapevolezza. L’attore è “funzionario” di una verità storica.
Al polo opposto, il teatro totalitario è retorico, enfatico, esaltato. Nei teatri fascisti si mettevano in scena drammi d’ispirazione romana o biografie epiche, spesso scritte da autori allineati come Giovacchino Forzano. Ma anche nella DDR, nei paesi comunisti, nei regimi autoritari latinoamericani, il teatro veniva controllato, censurato, plasmato per trasmettere messaggi conformi. Le rappresentazioni diventavano liturgie civili.
Contro tutto ciò si alzano le voci del teatro dell’assurdo, del teatro povero, del teatro performativo. Beckett, Ionesco, Kantor, Grotowski, Barba: artisti che scardinano ogni impianto ideologico, ogni sistema, anche quello della logica. Il messaggio, se c’è, è spiazzante. È una forma di propaganda negativa, che si fa domanda, vertigine, silenzio.
Narrativa: parole che costruiscono mondi
Nella letteratura, la propaganda ha un doppio volto: può essere esplicita, diretta, dichiarata, oppure insinuarsi tra le pieghe del romanzo, nei non detti, nelle atmosfere, nella scelta dei personaggi e delle trame. Durante il fascismo, gli scrittori erano invitati a celebrare la “romanità”, l’eroismo, la virilità: e infatti molti romanzi storici del tempo – anche formalmente notevoli – trasudano retorica patriottica. Nel mondo sovietico, il realismo socialista imponeva modelli di comportamento e figure idealizzate del lavoratore, del militante, dell’ingegnere.
Ma ci sono scrittori che hanno usato proprio la forma del romanzo per sabotare queste narrazioni. Bulgakov con Il Maestro e Margherita costruisce una satira sulfurea del potere; Pasternak con Il dottor Živago restituisce alla storia la sua complessità poetica e tragica. E più tardi, Kundera, Grass, Márquez, Calvino riescono a trasformare la narrazione in un atto di resistenza ontologica: scrivere per salvare le sfumature, l’ambiguità, l’umano.
Il romanzo è propaganda anche quando parla d’amore, di memoria, di lutto: perché ogni scelta narrativa implica un’idea di mondo. Se la propaganda istituzionale vuole convincere, la grande narrativa vuole far vedere. In questo senso, ogni romanzo è politico. Anche un racconto apparentemente intimo, se scritto con onestà, può disinnescare cliché, mostrare contraddizioni, restituire complessità.
E così, come in un quadro rinascimentale, le arti si dispongono in cerchio attorno al potere: a volte lo adorano, a volte lo sfidano, a volte lo riflettono senza giudizio. Ma mai, davvero, lo ignorano.
Oltre la propaganda: presente e futuri dell’estetica
Nel nostro tempo iperconnesso, ogni gesto, ogni immagine, ogni parola è potenzialmente un atto di propaganda. Non perché sia deliberatamente concepito per esserlo, ma perché tutto – nella società della visibilità – può diventare segno, rappresentazione, indicazione di appartenenza. L’arte, che per secoli si è posta come spazio di riflessione, di enigma, di tensione tra senso e forma, oggi si trova a operare in un contesto in cui l’estetico è ovunque, ma spesso svuotato della sua funzione critica. L’ornamentale e il simbolico, il patetico e il patinato si confondono. Il rischio, insidioso, non è tanto quello della censura esplicita – tipica dei regimi autoritari del Novecento – quanto quello della conformità estetica, della produzione compulsiva di senso condiviso.
Siamo nell’epoca della propaganda liquida. Una propaganda che non si impone con divise e inni, ma si insinua attraverso l’estetica dell’esperienza, del sé, del consumo emozionale. La pubblicità, che un tempo imitava l’arte, oggi la ingloba, la trasforma in superficie vendibile. Le grandi aziende non promuovono più semplicemente un prodotto: vendono visioni del mondo, atmosfere, etiche precotte, stili di vita. Apple, Nike, Patagonia, IKEA: ogni marchio è un microcosmo estetico che promette non solo funzionalità, ma significato, appartenenza, identità. E molti artisti si trovano schiacciati tra l’alternativa – spesso fittizia – tra autonomia e collaborazione, tra marginalità e sponsorizzazione.
Nel mondo digitale, ogni estetica è data-driven. Le piattaforme non solo diffondono contenuti, ma ne modellano la forma. Il design di Instagram, la brevità dei reel, la logica virale di TikTok, i filtri di Snapchat, il ritmo dei podcast: tutto contribuisce a delineare una grammatica estetica invisibile, ma potentissima. E questa grammatica ha un fine preciso: attrarre, trattenere, fidelizzare. L’estetica, oggi, è ottimizzata. E l’arte che resiste a questa ottimizzazione – lenta, difficile, ambigua – rischia di essere relegata ai margini, invisibile nel rumore.
Il problema non è solo che cosa l’arte comunica, ma come. L’ideologia contemporanea si nasconde dietro il gesto estetico stesso: nel frame, nella scelta della palette, nella costruzione della narrazione. La cosiddetta “estetica dell’autenticità” è spesso solo una strategia retorica per mascherare l’omologazione. L’artista che “parla con la propria voce” è spesso solo l’ennesima iterazione di un linguaggio già accettato, già riconosciuto dal mercato e dalla comunità culturale.
Eppure, qualcosa accade. Sempre. Vi è una linea di fuga che attraversa la storia dell’arte: quella del perturbante, del non addomesticato, dell’eccesso. Oggi essa prende forme nuove: l’arte algoritmica, ad esempio, che esplora il confine tra umano e macchina; oppure le pratiche ecologiche e site-specific, che sfuggono alla riproducibilità; o ancora le esperienze immersive e rituali, che si oppongono alla fruizione distratta. Queste modalità non si pongono solo come estetiche alternative, ma come forme di resistenza all’ideologia pervasiva. Creano buchi nel tessuto del visibile, punti ciechi dove la propaganda non penetra.
Ma si può ancora parlare di arte impegnata, oggi? Oppure siamo ormai oltre quella logica binaria – arte autonoma vs arte militante – che ha attraversato tutto il Novecento? Forse la sfida attuale è pensare un’estetica post-propagandistica, che non rinunci all’intervento sul reale, ma lo faccia con strumenti nuovi: ironia, dissonanza, ambiguità, lentezza, frammentazione. In un mondo che semplifica, l’arte può complicare. In un mondo che grida, può bisbigliare. In un mondo che mostra tutto, può oscurare. E in questo gesto inutile, risiede forse il suo potere.
Nel contempo, l’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il modo di produrre, distribuire e percepire l’estetico. Opere generate da AI, performance sintetiche, avatar che espongono nei musei, curatori automatici: tutto questo interroga il concetto stesso di intenzionalità artistica. Se un’opera è generata da un algoritmo, può essere ancora “propaganda”? E se sì, di chi? Dell’artista umano che l’ha istruito? Della macchina? Del sistema che l’ha addestrata? L’estetica si dissocia dall’autore, e in questa dissociazione si apre una nuova fase, dove anche la propaganda può diventare impersonale, neutrale, sistemica. Un’estetica senza soggetto, una bellezza anonima, tanto più pericolosa perché priva di responsabilità.
Nel futuro prossimo, dunque, potremmo assistere a una biforcazione: da un lato, un’estetica sempre più integrata, funzionale, simile a un linguaggio pubblicitario totalizzante; dall’altro, micro-esperienze artistiche marginali, sperimentali, antieconomiche, che cercheranno nuovi modi per sfuggire alla cattura. Forse torneranno in auge le pratiche clandestine, l’oralità, la performance effimera, l’arte situata, che esiste solo lì e ora, e poi scompare. Forse, come nei secoli più bui, l’arte ritroverà la sua forza nell’essere invisibile.
Ma è anche possibile – e auspicabile – che emerga una nuova consapevolezza critica, capace di riconoscere i meccanismi propagandistici impliciti nell’estetica contemporanea, e di rispondere con nuove forme, nuove etiche, nuove ecologie del visibile. Una pedagogia dell’immagine, una grammatica della complessità, una poetica della lentezza. Perché se la propaganda semplifica, l’arte può – ancora – rendere il mondo più difficile da decifrare. E quindi più libero.
In fondo, come ricordava Italo Calvino, l’estetica non è un lusso, ma una necessità dell’intelligenza. Non ci salva, forse. Ma ci sveglia.
La domanda resta, e non è una domanda qualunque: è un rovello antico, una vertigine che attraversa secoli di pratica e teoria, una sfida che ogni artista, ogni spettatore, ogni critico consapevole si trova prima o poi a contemplare, magari senza riuscire a formularla del tutto. Può esistere un’arte davvero libera? Una forma espressiva che non sia contaminata, nemmeno in modo impercettibile, dalle infinite pressioni esterne che agiscono sul gesto creativo? È pensabile un’immagine, un suono, un corpo in scena, una parola scritta che non porti in sé l’eco – più o meno conscia – di un sistema di pensiero, di un posizionamento, di una cultura, di una ferita personale o collettiva? Possiamo davvero, anche solo per un istante, credere che un’opera d’arte sia una bolla sospesa nel vuoto, priva di peso, di intenzione, di ombre?
O dobbiamo arrenderci all’idea, più complessa ma forse più autentica, che ogni forma artistica, persino la più minimalista o la più astratta, sia sempre – consapevolmente o meno – una forma di propaganda? Non propaganda nel senso più crudo e deteriore del termine, come strumento per imporre un dogma o manipolare le masse, ma nel senso più ampio: un veicolo che trasmette qualcosa, che promuove, che difende o mette in discussione un’idea del mondo, un’identità, un modo di stare al mondo, un sogno, un’utopia, una ferita. Anche quando un’opera sembra non voler dire nulla, quel nulla è già una posizione. Anche il silenzio, in arte, ha un colore, un accento, una grammatica.
E allora, se la libertà come assenza di condizionamenti è una chimera, forse dobbiamo spostare la nostra attenzione altrove. Forse non è la neutralità l’obiettivo – e tantomeno la pretesa oggettività – ma piuttosto una forma di consapevolezza radicale. Una consapevolezza che non si limiti a riconoscere i limiti esterni, le strutture storiche, politiche, culturali, ma che si estenda anche al riconoscimento delle proprie urgenze interiori, dei propri desideri, delle proprie contraddizioni. Un’arte davvero viva – se mai esiste – è forse quella che sa di non essere mai del tutto libera, ma che proprio per questo si interroga costantemente sul proprio senso, sul proprio posizionamento, sulla propria responsabilità.
Perché ogni immagine – ogni immagine – è un nodo di senso, un crocevia di tensioni. È un oggetto che parla, che significa, che agisce. E spesso agisce in modo più profondo e duraturo di un discorso articolato. Non basta evocare la bellezza, non basta cercare lo stile: bisogna saper reggere lo sguardo dell’altro, bisogna interrogarsi su che cosa accade quando un’immagine viene vista, quando una parola viene letta, quando un gesto viene ricordato. L’arte è un potere sottile – e in questo sta il suo fascino, ma anche il suo rischio. È un potere che può suscitare empatia o violenza, che può aprire orizzonti o chiudere porte. Un potere che può guarire, ma anche manipolare, affascinare e travolgere. Non c’è mai innocenza, del tutto, in un’opera d’arte: c’è sempre un residuo, una pressione, un’intenzione – anche se nascosta.
Per questo, più che di purezza, dovremmo parlare di onestà. Un’onestà profonda, spietata a volte, che comincia da chi crea ma non si esaurisce lì. L’onestà di riconoscere che il proprio sguardo non è mai neutro, che ogni gesto si colloca dentro una rete di significati, che anche la scelta di non scegliere è una scelta. Un’onestà che accetta la complessità, che non cerca scorciatoie, che non finge ingenuità. Un’onestà che non si vergogna di dichiarare un’appartenenza, una ferita, una lotta, un amore. Un’onestà che si esercita nella costruzione quotidiana del proprio linguaggio, nella pazienza con cui si ascoltano le reazioni, anche quelle ostili, anche quelle fraintese.
L’onestà, in fondo, è il gesto più rivoluzionario che un artista possa compiere: perché non consola, non protegge, non difende. Espone. Espone alla luce ciò che normalmente resta nell’ombra, mostra le cuciture, i dubbi, le fratture. E così facendo restituisce all’opera una forza più duratura, più autentica, più necessaria. L’opera d’arte, allora, non è un oggetto da esibire o da vendere, ma un luogo in cui accade qualcosa. Un campo di forze, una soglia, un’eco.
Perché ogni immagine – che lo si voglia o no – parla. Ogni immagine dice. E ciò che dice – o tace – non è mai neutro, non è mai vuoto. Ha sempre una ricaduta, un effetto, un’eco che si propaga nel tempo, nei corpi, nei sogni. Ed è in questa consapevolezza che forse si gioca, davvero, la possibilità di un’arte che non sia né prigioniera né illusa. Ma umana, intensamente umana.
(16 aprile 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata