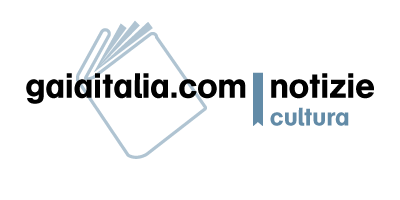Abbandoniamo il palco B del Fringe Festival sul quale abbiamo appena visto rappresentato #DeCamera, lasciando alle spalle la meraviglia imponente di Castel S.Angelo, attraversiamo Piazza Cavour e imbocchiamo Via Colonna. Mentre sfogliamo mentalmente le nostre impressioni alla ricerca di una parola, una scintilla che accenda la punta della penna e dipinga sulla tela virtuale la trasposizione dei nostri pensieri, lungo la strada un motorino con due ragazze sfreccia e si odono le loro corde vocali scandire monosillabi “po, po, po.” Poco dopo, dietro noi, tre ragazzi intonano lo stesso rituale composto di “po, po, po”. Alla capiamo improvvisamente di come la lingua, intesa come linguaggio colto, poetico, letterario, o semplicemente un parlato che non assomigli ad un verso – non poetico, ma animalesco – sia ormai una forma desueta. Si muore a colpi di monosillabi, “po, po, po”. E capiamo, anche, di come il teatro – bello o brutto che sia – sia lì, ancora, come una colonna sempre più fragile per acuire la nostra sensibilità. Ogni spettacolo è un imprinting che fa nascere tutta una lunga trafila di riflessioni sulla realtà circostante, improvvisamente certi aspetti della vita ci balzano agli occhi, proprio grazie al teatro, il quale ci ha spinto a soffermarci un po’ di più su quel “po, po, po” che certamente abbiamo già ascoltato altre volte lasciandolo cadere nel vuoto. Oggi lo abbiamo recepito, e questo anche grazie a #DeCamera, spettacolo che poi non ci ha nemmeno molto convinto.
#DeCamera, un titolo che possiede il simbolo che è forse l’icona più nota del 2.0: l’hashtag. Con questo l’autore ha voluto dare subito un segnale su cosa si stesse rappresentando, qualcosa di moderno, di contemporaneo, non un hashtag messo a caso, ma l’obiettivo preciso di dare degli indizi che avremmo assistito a qualcosa che da vicino ci riguarda: la nostra vita ai tempi di internet. O meglio, così almeno ci spiega la sinossi, che riportiamo: Una donna decide di chiudersi per 10 giorni nella sua stanza. Uno spazio dove resta viva solo la luce dello schermo del computer. Inizia così una reclusione volontaria dove la stanza si trasforma in un luogo affollato, abitato dalle storie di tutti quelli che, in connessione virtuale, si raccontano a uno schermo. Il pubblico ha la possibilità di sbirciare dalla toppa della serratura di un mondo fantastico dove tutto è concesso. (…). Questo è parte ci ciò che contiene la sinossi, per fortuna. Perché dal punto di vista della trama lo spettacolo è assolutamente illegibile: non si fa minimo accenno ai 10 giorni di reclusione – ma dato che si prende spunto dal Decamerone di Boccaccio non specificato in sinossi, e lasciato all’intuizione di ognuno dato è vox populi [sic] che Decameron in greco significa “dieci giorni”. Si intuisce appena qualcosa di più riguardo al mondo di internet grazie alle proiezioni e al piccolo portatile che ad un certo punto entra in scena e a volte si ricordano di usare perché in fondo si sta facendo uno spettacolo sui social network (?) – il sottotilo è “come i social network ci hanno (s)cambiato la vita; e non ultima questa intimità presunta con la quale sbirciamo nella toppa, non ci è arrivata. Dunque lo spettacolo nella sua forma ai nostri occhi si presenta come un mix di generi leggermente pasticciato, dalla recitazione un tantino aulica agli accenni di teatro danza e corporeo, al modernissimo videoproiettore, fino allo rottura dell’involucro magico che viene dall’abbattimento della quarta parete con le due attrici che vengono ad accarezzare il pubblico. La lettura diventa davvero difficile o indecifrabile per un profano, ciò allontana il pubblico anziché creare nuova affezione e diventa uno spettacolo d’elite (un tantinello snob, ma l’elite cos’è del resto?) – ammeso che quest’ultima apprezzi – che cerca di attrarre attraverso una sinossi fuorviante.
Ciò che in concreto si vede invece, è la messa in scena di alcuni passi del Boccaccio, nelle fantasie di questa donna “autoreclusasi” in casa, mentre sullo schermo prendono vita alcune comparse videoproiettate ed i Tweet di Giovanni Boccaccio, che cita parti del suo Decameron con tanto di #hashtag. Non ultimo assistiamo ad un posticcio social network dal linguaggio antico e dotto, nel quale non c’è il tasto “mi piace” ma “mi aggrada”, o dove si stringe amistà, e i post più recenti sono di pochi minuti “innanzi”. Su questo schermo gigante assistiamo anche allo scambio di condivisioni tra il Guardastagno e il Rossiglione. Tutto questo ci ricorda un po’ quelle pagine satiriche che sono appunto sui social network, all’interno delle quali i profili di noti scrittori del passato si scambiano like e commenti. Un sorrisetto, nulla più. Tra i tre palchi delle ore 22,00, questo era quello che più ci aveva attirato, ma il senso di delusione è forte e tangibile, soprattutto per essere stati adescati con l’inganno. Se si vuole rappresentare Boccaccio lo si faccia pure, ma se vi è un’idea più profonda di analisi della modernità, allora va approfondita e resa leggibile. Perché questo è un teatro che allontana più che avvicinare, è un teatro che gira intorno al problema anziché affrontarlo di petto, è un teatro che vuole mettersi in qualche modo su un piedistallo con fare accademico anziché andare a pungolare il pensiero. Un teatro che quasi prende le distanze e non vuole essere interpretato, ma è fine a se stesso. Non crediamo che tutto debba essere spiegato, ma nemmeno totalmente nascosto; non crediamo nemmeno che si debba sempre essere una nicchia, è bello aprirsi e provare a dire “questo è il teatro, ed è di tutti, siate i benvenuti”. E se l’obiettivo non è solo poesia, ma anche indagine sul contemporaneo, lo si indaghi, profondamente, con il contemporaneo; un #hashtag non è certo sufficiente. Nota positiva tuttavia sono le due attrici Alessia Candido e Chiara Cosentino. Questo è ciò che crediamo e ci ha ispirato #DeCamera: or messeri se ciò non v’aggrada toglietemi pure l’amistà.
(9 giugno 2015)
©gaiaitalia.com 2015 ©sandro giovanoli – diritti riservati, riproduzione vietata