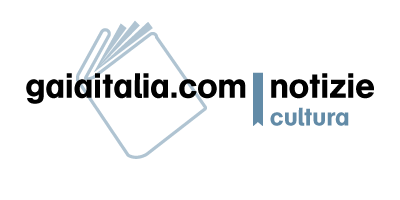di Alessandro Paesano twitter@Ale_Paesano

La ricerca drammaturgica di Giovanni Firpo, che presenta Hypnagogia come saggio di diploma in regia all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, indaga il sogno numinoso allestendone un’istantanea di un certo suo immaginario collettivo contemporaneo, maschile ed eterosessuale.
Mentre il pubblico sta ancora prendendo posto in sala, su delle sedie poste in file rarefatte a una distanza tale l’una dall’altra da rendere impossibile non solo il contatto fisico ma qualunque empatia tra persone (anche se si è venuti o venute in compagnia allo spettacolo si assiste in solitaria) gli e le interpreti sono già in scena immobili, eppure brulicanti, forti di una complessità pre-narrativa, che costituisce un vero e proprio glifo drammaturgico.
Una donna esanime è riversa sul letto di una stanza d’albergo, in una posa omologa a quella de L’incubo di Füssli, circondata da tre presenze, inquietanti e impassibili, una donna dal viso senza connotati (a esclusione delle labbra bistrate da un rossetto vermiglio), una governante prosperosa e un uomo dalla testa di coniglio.
Sulla parete opposta, quasi di proscenio, un ragazzo, si muove visibilmente turbato, l’unico ad apparire vero e vivo.
Pochi gli elementi di scena, al di là il letto una finestra e, accanto, una porta con un intarsio di vetro, alla sinistra delle quali sono uno specchio con un lavandino (funzionante) e, infine, un mobile basso di fronte al letto.
La scenografia (splendida, di Bruno Buonincontri, mentre i costumi altrettanto convincenti sono di Saverio Galano) si fa espressione della geometrica precisione di uno spazio onirico e ipnotico complici le luci (di Sergio Ciattaglia) che isolano o sottolineano un dettaglio della scena, un suo singolo componente, ovvero l’insieme illuminato ora dall’alto ora frontalmente rendendolo ogni volta lo stesso ambiente sempre diverso; luci impiegate anche per disegnare delle silhouette che spiccano in trasparenza al di là della porta e della finestra e, presto, anche dello specchio che si anima delle stesse inquietanti presenze, le sagome dei personaggi che abbiamo già visto e che entrano e escono dalla stanza popolando il palcoscenico doppio, quello teatrale e quello mentale delle rielaborazioni oniriche del giovane protagonista.
La partitura musicale, di Francesco Leineri, pervasiva ma mai invadente, sostiene più che suscitare le emozioni del pubblico, dettate da delle presenze sempre un poco inquietanti, un poco disturbanti perché sembrano parlare al pubblico in una maniera diretta al di là della stessa messinscena.
Lo spettacolo non è sostenuto da alcuna progressione tradizionalmente narrativa né da parola alcuna, ogni volta che si crede di avere capito il significato simbolico di un qualche dettaglio di scena (la pistola, il rossetto, la testa di coniglio) ecco che lo stesso viene riproposto in una contestualizzazione che contraddice qualunque ermeneutica a caldo il pubblico possa azzardare.
Firpo riesce a mettere in scena invece di limitarsi a mostrare quell’impossibilità narrativa, quell’aleatorietà de-significante del sogno i cui dettagli sono sostenuti in una magica e splendida coerenza che va irrimediabilmente persa appena ci svegliamo e invece di viverlo cominciamo a ricordarlo.
Più che la rievocazione di un sogno quella messa in scena da Firpo è il suo accadere nel qui e ora della performance teatrale che trae quella forza e quella coerenza oniriche dall’Aura di unicità che il teatro, come ogni forma d’arte performativa, mantiene integra anche in un’epoca in cui, come ricordava Benjamin quasi un secolo fa, la riproducibilità tecnica l’ha fatta perdere a ogni altra forma artistica (cinema e fotografia in primis).
Solo nella performance Firpo può imbastire una dinamica a-narrativa credibile e concreta usando la messinscena come correlativo oggettivo di quella autonoma e misteriosa del sogno per alimentare la fantasia de-narrativa del quale ha attinto anche dall’improvvisazione degli e delle interpreti durante le prove i cui risultati sono stati poi tradotti (è Firpo a usare questo verbo) per la scena.

I riferimenti intertestuali, evidenti e icastici, non servono né da ispirazione al discorso drammaturgico né come mero esercizio connotativo quanto, a indicare l’importanza che la narrativa popolare letteraria (Allan Poe) quanto cinematografica (David Lynch, Richard Kelly) siano strumenti essenziali anche della ipnopoiesi.
Le storie sui sogni contribuiscono allo sviluppo e all’articolazione dei sogni proprio nello stesso modo in cui le storie durante la veglia aiutano a fare di quanto ci capita vivere, una esperienza ordinata e fornita di senso.
D’altronde se il sogno è anche rielaborazione fantastica di quanto non riusciamo a spiegarci (o di cui non volgiamo renderci conto) durante lo stato di veglia, le stesse strutture narrative che impariamo incosciamente a usare come strumenti di razionalizzazione di un’esistenza altrimenti essenzialmente aleatoria, possono costituire strumento immaginativo e creativo del mondo onirico.
E’ nel sogno che ammettiamo a noi stessi di autoingannarci quando ci ostiniamo a credere alla intelligibilità della vita nello stato di veglia, una intelligibilità illusoria visto che q uel che ci accade nel mondo non ha mai quella coerenza alla quale abbiamo bisogno di credere ma è mossa dalle stesse leggi pre-logiche refrattarie a ogni ordine deterministico del sogno.
Firpo fa riverberare alcune corde universali di certo immaginario umano maschile e eteronormato (lo diciamo una volta tanto senza alcuna valenza negativa) in una chiave vicina a uno Jung rivisto e corretto da certa letteratura e certo cinema americani.
Per quanto tentati oltremisura di fornire delle letture ermeneutiche che diano un senso narrativo alla drammaturgia per immagini, luci, musica e regia, lo spettacolo vi si oppone pervicacemente.
Ci si riesce a farlo solo a livello personale proprio come personali sono i sogni di ognuna e ognuno di noi.
Nulla ci impedisce di indicare però alcuni elementi che emergono durante l’avvicendarsi di queste anime oniriche che si cercano e si bramano con erotismo e tanta minacciosa paura della morte.
La pistola che passa di mano in mano, il rossetto che orna la bocca della donna senza volto ma sporca anche la faccia del protagonista, lasciandogli una traccia rosso sangue anche sulle mani, sono un evidente rimando al fallo, al sesso penetrativo, alla deflorazione, allo stupro, alla sopraffazione del maschio sulla femmina.
L’atto penetrativo, lo stupro, alludono anche a una procreazione abortiva se bene intendiamo quel che la governante estrae dalle gambe della giovane donna riversa sul letto.
Al contempo sono anche immagini numinose dell’incombete responsabilità del ruoli di genere maschile che come ogni potere implica il rischio della sua perdita del rispetto e del riconoscimento di quella stessa autorità misconosciuta da parte della donna, una numinosità del femminino rappresentata da un paio di décolleté rosse, una delle quali si muove da sola sulla scena.
L’incubo del protagonista è dunque quello di un giovane uomo eterosessuale vittima di un patriarcato che sembra sempre di meno governare e sempre più subire senza mai capirlo fino in fondo, come sembra concludersi lo spettacolo con un controglifo che vede il protagonista stesso al posto della donna, riverso a letto, non più soggetto ma oggetto del sogno se non è sempre stato così…
Non mancano nello svolgersi dell’azione scenica, solo apparentemente spontanea, in realtà misurata in ogni minimo movimento, al limite della coreografia, un numero cospicuo di eleganti e mai ostentati coup de théâtre, dallo spostamento dei personaggi nelle varie parti della scena, grazie a brevissimi subitanei bui, all’uscita di un personaggio dal mobile basso di fronte al letto alla scomparsa del protagonista sotto il letto come inghiottito da uno spazio che non c’è.
Firpa sa muoversi bene su questo registro registico sapendo giocare con polso fermo e senza indulgere nella dimostratività la specificità del teatro che sa restituire, performare e mettere in scena il sogno in una maniera più profonda, più seducente, più convincente del cinema.
Per cui i riferimenti intertestuali che abitano Hypnagogia più che degli omaggi al cinema che istaurerebbero delle gerarchie, costituiscono dei furti, il risultato delle ombre lunghe del sogno che dal teatro arrivano all’immaginario cinematografico riportandone in scena alcuni regesti.
Bravissimi e bravissime gli e le interpreti (Vittoria Faro, Antonio Orlando, Carola Ripani, Giulia Trippetta e lo stesso Firpo) capaci non solo del giusto linguaggio del corpo ma anche della necessaria resistenza fisica a una partitura di movimento che richiede delle doti para-atletiche.
Hypnagogia dimostra, se ce ne fosse bisogno, che l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico sa come formare attori e attrici.
Forse avrebbe giovato qualche taglio a certa ridondanza pletorica (la donna con la testa di porco portata al guinzaglio dalla donna senza volto, l’uomo coniglio che si ripropone uomo cavallo) eccessive e non necessarie nell’economia dello svolgimento del sogno, oppure, al contrario, avrebbero necessitato di un tempo maggiore di elaborazione per apparire drammaturgicamente credibili mentre così come sono tradiscono una certa voglia di strafare rimando irrisolte.
Nulla che non possa essere aggiustato nelle repliche future di uno spettacolo al quale auguriamo una vita lunga e tante riprese perché Hypnagogia dimostra quanto nonostante la crisi il teatro sia tutt’altro che morto e le Accademie d’Arte svolgano ancora bene il loro lavoro.
Almeno quando chi le frequenta ha qualcosa da dire e Giovanni Firpo con Hypnagogia di cose da dire ne ha molte…
(22 dicembre 2015)
©gaiaitalia.com 2015 – diritti riservati, riproduzione vietata