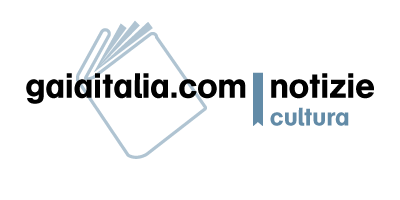di Alessandro Paesano twitter@Ale_Paesano
di Alessandro Paesano twitter@Ale_Paesano
Il fare teatrale di She She Pop, collettivo fondato alla fine del 1990 dalle laureate del programma Applied Theater Studies di Gießen, ha il suo fulcro drammaturgico nel nesso tra la responsabilità individuale e quella collettiva.
Una responsabilità declinata secondo il sesso di appartenenza, che nella collettività si trasforma in genere con le sue aspettative prescrittive, i suoi ruoli e i suoi stereotipi, e anche secondo la propria storia personale, familiare e affettiva.
Ogni performer sviluppa il proprio punto di vista in base al suo orizzonte personale e la propria esperienza. Questa cosa alcuni la definiscono “teatro autobiografico”. Tuttavia, i riferimenti fatti da noi per le nostre vite sono in realtà un metodo e non il contenuto del nostro lavoro. Condensiamo il nostro materiale personale in una strategia artistica riconoscibile e secondo le posizioni stilizzate come si legge nel programma di sala.
She She Pop – si legge ancora – è un collettivo femminile. L’esistenza di membri maschili e di collaboratori non ha che poca influenza su questa cosa. (…) L’atto di presentarci ad un pubblico come un gruppo di (soprattutto) donne – di tutte le cose – è per noi sempre qualcosa su cui riflettiamo e da cui osserviamo, sopra e dietro, il palco.
Questo modo di lavorare non lascia spazio all’approssimazione o alla sporcatura spontaneistica dell’esecuzione, al contrario, il lavoro di She She Pop si caratterizza per una precisione dell’esecuzione e un nitore formale esemplari.
Nell’allestimento presentato a Short Theater insieme alle loro madri, She She Pop mettono in scena una cerimonia totale, a cui sono invitate a partecipare anche le spettatrici (e gli spettatori, beninteso).
Il testo che ha ispirato il collettivo è La Sagra (nel senso di rito) della Primavera Igor Stravinsky, le musiche per il balletto di Diaghilev coreografato da Nijinsky messo in scena nel 1913 nel quale il compositore affronta il tema del sacrificio (di una vergine) che dovrà ballare sino alla morte per propiziare gli dei.
Partendo dal rifiuto di questa idea dei sacrificio (qual è lo scopo del sacrificio?) She She Pop cerca una risposta collettiva e la trova con l’ausilio delle proprie madri.
Quattro performer in scena, tre donne e un uomo, interagiscono con le proiezioni video delle rispettive madri, ognuna proiettata su una striscia verticale che occupa tutto il palco in orizzontale, ogni strisca distanziata in modo che le e il performer possano attraversare i teli di proiezione per nascondervisi dietro e tornare a interagire davanti.
L’indagine sul sacrificio non verte tanto sulle origini arcaiche del mito rielaborato da Stravinsky quanto sul significato moderno, contemporaneo del sacrificio e si dipana subito nella doppia cifra del biografismo: il rapporto tra performer e madri e tra madri e performer. Ne nasce una indagine a doppio senso dove le aspettative della prole fanno da specchio a quelle delle madri in un rispecchiamento continuo tra ruoli sociali ruoli materni e filiali dove nulla viene dato per scontato e dove il dato autobiografico non è mai fine a sé stesso, ma sempre materia umana da mettere in comune con il pubblico in sala.
A questa ricerca sviluppata dialogicamente (forse un poco eccessiva rispetto la parte performativa) fa da contraltare una parte drammaturgica nella quale le e il performer interagiscono in maniera dinamica con le videoproiezioni materne (una spinta al telo di proiezione causa un rinculo nella figura proiettata della madre, etc.). Ancora e di più le e il performer interagiscono anche attraverso una seconda videoproiezione, che riprendendo dal vivo i loro movimenti, li proietta sulle immagini materne ottenendo sovrapposizioni che ricordano il linguaggio del cinema muto. Così figlie e figlio possono accoccolarsi nei ventri materni (anche se le madri sono ageé e al di là di ogni possibile fertilità) o, viceversa la presenza numinosa delle madri può emergere da dentro il corpo della prole. In uno scambio continuo di ruoli dove la dimensione ingigantita delle madri (in proiezione) e l’interazione tra una strisca e l’altra tra le figure delle madri proiettate, rendono questa partitura visiva una concertazione coreografata (proprio come il balletto cui si ispira) dove ogni movimento deve essere calcolato al millimetro perché la registrazione video nona attende né può correggere un errore di tempistica.
Ne risulta un lavoro perfetto che restituisce il sacrificio del femminile in una società maschilista e sessista come quella occidentale contemporanea (queste donne per quanto artiste o professioniste hanno dovuto rinunciare alla propria vita prematrimoniale per diventare madri e mogli), ma dove il femminino ha delle responsabilità nei confronti della prole in un continuo processo di rispecchiamento narcisistico (in termini psicanalitici) inevitabile. E che ogni figlia, ogni figlio, deve affrontare con la propria madre (o la figura che comunque facendogli da specchio gli e le ha permesso di distinguere un sé dal mondo esterno, un soggetto dall’oggetto). E non sempre questo accade…
La proiezione delle madri sulle figlie (e sul figlio) e viceversa, nella sua valenza polisemantica del termine proiettare (cinematografico, psicanalitico, archetipico, immaginifico) così come i ruoli di genere con l’impatto diverso che la figura materna ha sul maschile e sul femminile socialmente definitivi, sono solo alcuni dei temi affrontati nello spettacolo che rimane una delle proposte più interessanti che abbiamo avuto la fortuna di vedere.
Il pubblico romano ha accolto questo splendido lavoro con una certa freddezza. Non vogliamo infierire sulle nostre e sui nostri connazionali ma la tentazione di citare il Pasolini che parla per bocca di Orson Wells ne La ricotta è davvero forte…
(6 settembre 2015)
©gaiaitalia.com 2015 – diritti riservati, riproduzione vietata