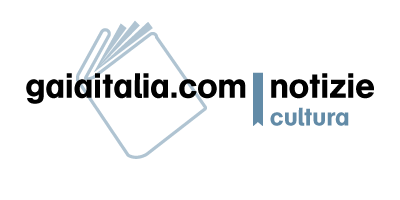di Alessandro Paesano twitter@Ale_Paesano
di Alessandro Paesano twitter@Ale_Paesano
Giornata ricca quella di Martedì 8 settembre a Short Theatre 10 con molte sorprese e qualche delusione.
Procediamo in rigoroso ordine di programmazione.
Gianni di e con Caroline Baglioni, testo vincitore del Premio Scenario per Ustica 2015, ci racconta delle fissazioni di un uomo in preda a problemi maniaco depressivi. A interpretarlo la giovane autrice attrice che, dopo essere apparsa in scena dal buio, gravata da un cumulo di scarpe dal quale sceglie due scarpe diverse da calzare, una col tacco, femminile, l’altra di foggia maschile, si fa corpo e mente di questo uomo, restituendone l’incedere del passo, la cadenza della voce, il romanesco alternato al toscano appena accennati oppure più marcati, mentre fuma una inesistente sigaretta come fosse la sua unica fonte di ossigeno.
Il monologo è narrativamente giustificato da un nastro che l’uomo sta registrando, consapevole delle ripetizioni che fa, registrazione che interrompe di tanto in tanto, per riascoltarsi. Il monologo diventa così più che una confessione l’evidenza di una difficoltà, quella di sottrarsi a una mania compulsiva, a una depressione, a uno stato di bisogno che riporta l’uomo sempre a un prima quando era più giovane e stava bene e faceva l’amore con le ragazze. Nella chiusa della piéce l’uomo in questione è ricollocato nella memoria adolescenziale del personaggio femminile che lo interpreta (una telefonata della polizia, il ritrovamento di una scarpa taglia 46) senza alcun personalismo, senza alcun riferimento a una dimensione intima o privata.
L’elemento biografico viene svelato alla fine, per onestà intellettuale, per completezza della performance, per restituire quel grumo di vita reale dal quale il testo è nato, dopo la comparsa (e la scomparsa) del personaggio dalla scena, dopo che il pubblico ha avuto modo di conoscerlo e incuriosirsene.
E alla fine della pièce mentre una sola luce rimane a illuminare la scarpa taglia 46, unico elemento che resta del personaggio, sentiamo la vera voce di Gianni in una delle sue registrazioni, apprezzando lo scarto tra questo materiale documentale e la perfomance che lo ha riletto, reinterpretato, cui abbiamo appena assistito in un continuo rimando tra l’uno e l’altra che conclude in maniera elegante un grande lavoro.
Straordinaria interprete, Caroline Baglioni non rifà il verso a Gianni, ma ne incarna l’essenza, la cifra esistenziale, fisica ed emotiva con una bravura che sorprende ancora di più quando vediamo l’attrice fuori personaggio venirsi a prendere gli applausi, meritatissimi, così lontana nella postura e nel linguaggio del corpo dal personaggio che ha appena smesso di interpretare.
Nella motivazione del premio Scenario si legge: “Colpisce la trasformazione di un materiale biografico intimo e drammatico in un percorso personale di ricerca performativa: la traccia audio originale di un’esistenza spezzata, come il testamento beckettiano di Krapp, ispira una partitura fisica, gestuale, coreografica in un efficace gioco tra due ambiti scenici che si rivelano anche esistenziali. Un lavoro sulla memoria individuale capace di creare uno spazio di comprensione ed empatia che scuote lo spettatore”.
Ecco un teatro che ci piace!
E che sia Short Theatre a darci l’opportunità di assistervi ce lo fa piacere ancora di più.
 Nell’ambito del progetto nell’ambito di Fabulamundi Playwriting Europe Lea Barletti e Werner Waas mettono in scena Tristezza&Malinconia o il più solo solissismo George di tutti tutti i tempi di Bonn Park (di origini coreane, nato a Berlino Ovest nel 1987 dove prende il nome dalla città), nella traduzione Alessandra Griffoni.
Nell’ambito del progetto nell’ambito di Fabulamundi Playwriting Europe Lea Barletti e Werner Waas mettono in scena Tristezza&Malinconia o il più solo solissismo George di tutti tutti i tempi di Bonn Park (di origini coreane, nato a Berlino Ovest nel 1987 dove prende il nome dalla città), nella traduzione Alessandra Griffoni.
Il testo racconta di una tartaruga di nome George, vecchia di oltre un miliardo di anni, l’ultima della sua specie, coi tempi dilatati da un’età così immensamente eterna viene introdotta alla platea da una voce narrante, una demiurga precisa, sollecita, didascalica, che si altera dello scarso entusiasmo di una creatura così longeva immaginando per lei inesistenti fini apocalittiche. Intanto una presenza fiabesca, una bambina – principessa – fata delle fiabe (magistralmente interpretata da Simona Senzacqua) compare per raccontare a George, indifferente, le avventure di Raperonzolo e la principessa dia capelli d’oro…
Lea Barletti incarna una narratrice che sa infervorarsi ma deve sempre rassegnarsi alla saggezza disincantata di chi ha vissuto da sempre e per sempre. Werner Waas dà a George tutto il disincanto della sua presenza scenica, apparentemente svagata e distratta ma invece sempre puntuale e attenta ai dettagli. Un testo che tesse un’elegante riflessione sulla vita e la morte sull’unicità dell’esistenza sul narcisismo dell’amore e sul disincanto di un impegno che si sgretola quando ci si sente addosso il peso di miliardi di anni. Una mise en espace esemplare nella quale il pubblico in sala viene coinvolto e messo in collegamento con gli astanti fuori dall’edificio quando Geroge\Waas apre le tende oscuranti della sala in cui si svolge lo spettacolo di modo che la platea è osservata dal di fuori dai e dalle passanti in uno scambi di sguardi che rende lo spettacolo una performance altra.
Un’altra delle perle di questa edizione del decennale di Short Theatre.
Poi viene la Danza, e dopo la coreografia Becoming di Youness Khoukhou, che abbiamo visto domenica, Mriziga ha presentato a Short Theatre una coreografia tutta sua, nell’ambito del progetto IYMA – International Young Makers in Action, in prima nazionale 55 (i minuti della sua durata). Da solo, in uno spazio scenico nel quale il pubblico prende posto sui quattro lati, Mriziga appoggia un gesso bianco, tre nastri adesivi da carozziere per terra poi inizia ad esplorare lo spazio, contando larghezza lunghezza e profondità del palco allestito nel corridoio centrale della Pelanda, mentre diversi nastri magnetici manovrati dal coreografo danzatore in successione, alternano suoni e silenzio, intessendo una partitura rarefatta, precisa e coordinata.
I movimenti di Mriziga che sono fluidi nonostante gli abiti borghesi che indossa (pantaloni camicia e maglioncino, mocassini e, addirittura, un anello al dito) ne limitino la portata. Movimenti lungo l’impiantito in piedi e movimenti sul pavimento, sdraiato, prono e supino. Movimenti che si ripetono disegnando nello spazio e nel tempo delle figure geometriche e che ben presto contribuiscono alla costruzione di un disegno geometrico. Prima dei timidi segni sull’impiantito lasciati dal gesso poi dei segni più decisi segnati con il nastro di carta manovrato con una grande perizia e sicurezza da Mriziga nel realizzare un disegno sempre più complesso che emerge da una geometria che è la risultante dei movimenti già provati nell’aria e sul pavimento che ora si traducono in una scrittura fisica per nastro una sorta di cronocoreutografia reinventata. La costruzione del movimento per la danza diventa causa di un’altra costruzione geometrica e grafica. Una restituzione grafica del disegno che si cela dietro ogni coreografia, un disegno inteso qui non solamente nel significato di fine o scopo, ma anche, se non soprattutto di costruzione geometrica, di assestamento nello spazio e nel tempo del corpo. Un corpo iscritto nello spazio in cui danza come l’uomo vitruviano è iscritto nel cerchio, lo stesso cerchio che Mriza con affascinante perizia facendo fulcro sul proprio gomito usa l’avambraccio come misura di raggio per disegnare con pochi tratti fermi e decisi dei cerchi quasi perfetti, primo nucleo di una costruzione geometrica via via più complessa. Un dialogo tra danza e performing art in una coreografia che tiene conte nel suo stesso farsi del luogo in cui viene realizzata.
 Il pubblico guarda, segue, si domanda, capisce, si meraviglia e si diverte e poi applaude, tanto.
Il pubblico guarda, segue, si domanda, capisce, si meraviglia e si diverte e poi applaude, tanto.
Fa piacere notare come dal nordafrica (Mriziga è di origini marocchine come Khoukhou) arrivino dei nuovi coreografi il cui ego non intossica le loro performance e coreografie, ma dove l’energia creatrice del gesto è sempre mitigata dall’intelligenza della modestia. Una lezione che molti coreografi e coreografe d’Italia tardano ad imparare. Va sottolineato che non è per casualità che il mondo dell’arte francese è territorio dei franco-maghrebini. Chapeau.
War now nasce come progetto per il centenario della Prima Guerra mondiale,
Da queste prime suggestioni Valters Sīlis e Teatro Sotterraneo hanno deciso di indagare gli effetti di una ipotetica (?) terza guerra mondiale. Ne nasce uno spettacolo diviso in tre parti (prima, durante e dopo, scandite da didascalie in inglese su immagini fin de siècle). L’idea stimolante di confrontare la retorica delle due guerre mondiali per trarne il dis-senno per lo sfacelo planetario di una ipotetica terza non riesce a dare unità a un discorso che rimante abbozzato.
Sara Bonaventura e Claudio Cirri ai quali si affianca Matteo Angius (in un organico ridotto rispetto quello presentato nel programma) interrogano nella prima parte il pubblico sulla liceità dell’uccisione di animali, prima, e sull’assassinio, dopo, componendo le prime riflessioni sugli effetti nefasti e improbabili di un nuovo conflitto mondiale.
Inizia poi la seconda parte, quella drammaturgicamente più debole, nella quale con una retorica narrativa del cinema (uno schermo usato come quinta trasparente attraverso la quale e dietro la quale avviene l’azione lo ribadisce in tutta la sua icasticità) vediamo un conflitto in cui degli invasi si difendono dagli invasori dopo che un summit con tutte le nazioni (i rappresentanti delle quali vengono scelti dal pubblico) non sortisce effetto alcuno.
L’azione si attesta sulle dinamiche narrative da seconda guerra mondiale così come siamo stati abituati e abituate a seguire da certo cinema americano con l’unica differenza che adesso anche le donne fanno la guerra. Questo elemento però non diventa occasione per un discorso sugli eserciti contemporanei ma sembra più una esigenza di organico visto che la compagnia annovera tra un’attrice.
Il racconto non coglie l’occasione di attestare le diverse sociologie delle due guerre mondiali (la Prima fatta da uomini, la Seconda sempre da uomini mentre le donne erano in fabbrica a costruire le armi, mentre l’eventuale terza vedrebbe entrambi i sessi in prima linea), ma si attesta su un immaginario maschile(ista) noiosamente eterosessista dove la storia d’amore è tra l’uomo e la donna e dove la violenza si rifà sui neonati (uccisi brutalmente) senza registrare gli orrori cui siamo stati introdotti almeno dalla guerra nella ex Jugoslavia in poi (per tacere delle prodezze fotografiche delle soldate in Medio Oriente…). La retorica del nemico che attacca è posticcia e quando l’invasore parla un italiano stentato con una flessione vagamente asiatica si sfiora il razzismo.
La seconda parte è priva di un centro narrativo forte e si distingue solamente per l’elegante scelta di restituire il monocromatismo delle scenografie e dei costumi con una serie di colori tendenti al grigio al blu al nero e al bianco.
Più riuscita la terza parte quella del dopo, della ricostruzione, che si rifà alla retorica del documento verità che caratterizza questo inizio di millennio.
A un anno dalla fine della guerra si inaugura un teatro nel quel vengono ricordati la mattanza degli innocenti (e rivediamo in ricostruzione teatrale lo stesso atto feroce compiuto su un infante visto nella seconda parte) la vera madre del bambino ucciso dice qualche parola tra le lacrime, il padre mutilato parla senza farsi comprendere e il fratellino dell’ucciso legge una poesia in rima, a cavallo tra retorica del ventennio e del futurismo. Si ride anche se a denti stretti ma stavolta il risultato è lontano dal rigore e dalla precisione cui Teatro Sotterraneo ci ha abituato.
Stavolta si fa fatica a vedere un oltre che al di là dell’elemento performativo indichi quel sostrato culturale che in tanti altri spettacoli emergeva chiaramente come sottotesto.
Stavolta il sottotesto non è né chiaro né preciso e parlare di una terza guerra mondiale serve più paradossalmente per tessere un elogio delle prime due guerre mondiali che per denunciare le guerre moderne del terzo millennio (che purtroppo anche se sono locali e non mondiali attanagliano il Pianeta proprio nel momento in cui io scrivo e voi leggete).
Stavolta il sottotesto rimane un esercizio di stile, poco ispirato e anche un poco grossier.
Ultimo spettacolo della ricca e intesa giornata è Homolgia, Menzione speciale al Premio Scenario 2015, di DispensaBarzotti.
Parliamo di questo spettacolo con un certo pudore per il rispetto che si deve sempre per il lavoro e l’impegno e la buona fede e la mancanza di presunzione o di un ego insaziabile.
Purtroppo però intavolato in scena da Riccardo Reina e Rocco Manfredi che firmano la regia assieme ad Alessandra Ventrella, non si distingue per chiarezza di intenti né il nitore drammaturgico.
 Questo anziano solitario che sonnecchia e segue col telecomando in mano una tv dalla quale emergono solamente vecchie pubblicità e che si rallegra quando all’improvviso dal nulla un manichino, giovane ragazzo, e poi suo sosia anziano, compare nella sua vita solitaria in un gioco di rispecchiamento dove uno fa il burattinaio dell’altro è troppo larvale per radicarsi in una drammaturgia che possa dirsi tale.
Questo anziano solitario che sonnecchia e segue col telecomando in mano una tv dalla quale emergono solamente vecchie pubblicità e che si rallegra quando all’improvviso dal nulla un manichino, giovane ragazzo, e poi suo sosia anziano, compare nella sua vita solitaria in un gioco di rispecchiamento dove uno fa il burattinaio dell’altro è troppo larvale per radicarsi in una drammaturgia che possa dirsi tale.
Più della perizia attoriale nel linguaggio del corpo, nella postura, prevale l’espressività verace della maschera che entrambi i performer indossano per impersonare il vecchio dove la maschera perde la sua funzione simbolica e diventa essa stessa personaggio la malinconia buffa dettata più dalla sua espressività che da quello che accade in scena…
A rischio di sembrare paternalisti è il caso di dire che gli autori e l’autrice sono forse troppo giovani per avere davvero qualcosa da dire sulla vecchiaia.
E i riferimenti a Beckett riportati nel programma di sala ricordano tanto certe ingenuità dei temi scritti al liceo…
(10 settembre 2015)
©gaiaitalia.com 2015 – diritti riservati, riproduzione vietata